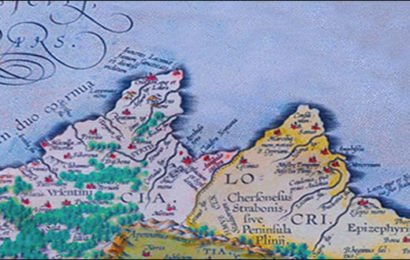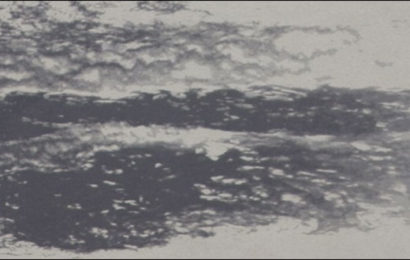di ROSSELLA FARNESE – Anime fragili e danneggiate, inquiete e disperatamente affamate di amore, vagano alla deriva, come animali in gabbia in un’abissale solitudine, sulla scena del teatro di Sarah Kane intesa come campo di battaglia, come luogo di conflitto, dove la drammaturga inglese – morta suicida all’età di ventotto anni, nel 1999, impiccata con i lacci delle sue scarpe a una maniglia dell’ospedale psichiatrico presso cui era stata ricoverata per overdose di sonniferi – indaga e denuncia il disagio esistenziale, l’orrore della realtà, la cupezza delle relazioni sociali vissute come incubo.
di ROSSELLA FARNESE – Anime fragili e danneggiate, inquiete e disperatamente affamate di amore, vagano alla deriva, come animali in gabbia in un’abissale solitudine, sulla scena del teatro di Sarah Kane intesa come campo di battaglia, come luogo di conflitto, dove la drammaturga inglese – morta suicida all’età di ventotto anni, nel 1999, impiccata con i lacci delle sue scarpe a una maniglia dell’ospedale psichiatrico presso cui era stata ricoverata per overdose di sonniferi – indaga e denuncia il disagio esistenziale, l’orrore della realtà, la cupezza delle relazioni sociali vissute come incubo.
Dialoghi-monologhi franti, frasi smozzicate intrecciate e riprese, frammenti di una comunicazione impossibile, parole inespresse e cariche di rabbia, di violenza, di ricordi, di erotismo, di disperazione e di richieste inappagate si snodano lungo le pagine di Tutto il teatro di Sarah Kane, edito Einaudi nel 2000 (pp. 224, € 15,00), a cura di Luca Scarlini e con traduzioni di Barbara Nativi.
L’antologia comprende i cinque testi teatrali della Kane, dai titoli lapidari e polisemici: Dannati, che nella scelta originale di Barbara Nativi, traduttrice e regista italiana dell’opera, manteneva l’inglese, Blasted, con tutta la possibile gamma di sfumature semantiche (distrutti, dilaniati, scoppiati) del termine; L’amore di Fedra, nato all’interno di un progetto di riscritture mitologiche promosso dal Gate Theatre di Londra; Purificati, in inglese Cleansed, che allude allo stesso tempo alle crudeli ferite morali e corporee e a una terribile pulizia etnica; Febbre, traduzione di Crave, inizialmente reso con Fame e Psicosi delle 4 e 48, che allude all’ora notturna che, secondo le statistiche, è il momento di maggiore attrazione verso il suicidio.
L’eccesso scenico e verbale è la cifra della drammaturgia della controversa Sarah Kane che, con un filo rosso sangue, rinvia al teatro elisabettiano, a Seneca e ad Euripide. Capofila della «new angry generation» britannica, il debutto della Kane è protagonista di una vicenda di isterismo censorio, un vero e proprio linciaggio da parte dei tabloid: all’indomani, infatti, della prima rappresentazione di Blasted, il 12 gennaio 1995 al Royal Court Theatre Upstairs di Londra con la regia di James Macdonald, un inferocito recensore scrisse sulle colonne del Daily Mail una critica furibonda, intitolata Una disgustosa sagra della schifezza.
Blasted è un crescendo di sopraffazioni e di violenze, ambientato in una lussuosa e claustrofobica stanza d’albergo e trasferisce a Leeds vicende simili a quelle della ex-Jugoslavia. La scena è il luogo di una battaglia interna tra Ian, giornalista da rotocalco senza scrupoli e senza illusioni e Cate, ragazza disturbata e che balbetta quando è sotto stress, è un blocco compatto di minacce e aggressioni poi replicate sul protagonista maschile da un soldato che irrompe nella stanza, siglando un ritmo circolare di efferatezze. La critica, pertanto, con una lettura superficiale, ha accusato l’autrice, banalizzandola, di mirare alla pulp fiction e di accumulare cadaveri e stupri per necessità pubblicitaria di scioccare gli spettatori.
Scrittura estrema e visionaria, orrori scenici, linguaggio minuzioso e violento con impennate liriche, assenza di trama e intersecarsi concitato di flusso di pensieri messi in bocca a personaggi che parlano senza mai guardarsi e che, come se venissero di volta in volta illuminati dai fari di un’auto per poi ritornare nel buio, sembrano scrutare lo spettatore attraverso la grata di un confessionale: questi gli elementi-chiave del teatro della Kane, che non è affatto una scrittrice monocorde che dà voce a un’esistenza sociale degradata parlando contro tutti e contro tutto, ma anzi, un classico della contemporaneità, sulla cui opera non è ancora stato compiuto uno studio approfondito.
L’amore di Fedra, rappresentato per la prima volta il 15 maggio 1996 al Gate Theatre di Londra con regia della stessa Kane, è una vera e propria dichiarazione di stile, un manifesto poetico. Si tratta di una rivisitazione in chiave moderna, pop, del mito di Fedra, senza alcun maligno rimando satirico alle cronache a luci rosse della casa reale inglese. Ippolito è un giovinastro grasso e debosciato che trascorre le giornate sul divano guardando la televisione, divorando junk food e facendo sesso per noia, in preda a un insuperabile spleen, esclama infatti: «Riempio le giornate di schifezze. Di robaccia, di schegge, mozziconi, vivacchio, Cristo infame». Il giorno del suo compleanno la matrigna Fedra gli confessa il suo amore ma lui le dice di essere andato a letto con Strofe, figlia di prime nozze di Fedra che, umiliata, si uccide lasciando un biglietto in cui scrive che il principe l’ha stuprata.
Ippolito viene quindi messo in prigione e un prete lo invita a redimersi per il bene della monarchia e per la stabilità del Paese, ma il ragazzo con la sua logica stringente lo seduce, spiega infatti: «E tu che suggerisci, una conversione in extremis, tanto per stare tranquilli? Di morire come se Dio ci fosse, sapendo che non c’è? No. Se Dio c’è, voglio guardarlo in faccia sapendo che sono morto come sono vissuto. Da peccatore […] Non posso peccare contro un Dio in cui non credo […] Io so cosa sono. E sarò sempre così. Ma tu. Tu pecchi sapendo che poi confesserai. E sarai perdonato. E ricomincerai tutto da capo. Come pensi di poter beffare un Dio tanto potente? Allora non credi veramente. […] Il libero arbitrio è l’unica cosa che ci distingue dagli animali. E io non ho intenzione di comportarmi come un animale. Quello lo lascio a te». Ippolito viene linciato dalla folla, mentre Strofe, che cerca sotto mentite spoglie di salvarlo, viene stuprata da Teseo, che quando riconosce l’identità della ragazza, si suicida. Ippolito, evirato da un coro di gente comune da talk show, muore con un sorriso dicendo: «ce ne volevano di più di momenti così», lieto di aver finalmente trovato un’emozione capace di risvegliarlo dal suo torpore esistenziale.
Purificati, andato in scena per la prima volta al Royal Court Theatre Downstairs di Londra il 30 aprile 1998 con la regia di James Macdonald, è stato scritto dalla Kane dopo aver letto un’affermazione di Roland Barthes: «essere innamorati è come essere ad Aushwitz». Le venti scene si svolgono in un campus universitario che diviene letteralmente un campo di concentramento dominato dal sadico Tinker, il cui nome è una trasparente allusione all’inferocito recensore di Blasted. I personaggi, Graham, morto per overdose di eroina, sua sorella Grace, Robin, ragazzino innamorato di Graham e gli omosessuali Carl e Rod, subiscono, a causa dei loro sentimenti non solo delle sofferenze emotive ma delle vere e proprie torture fisiche inflitte da Tinker, che usa i loro corpi per il proprio piacere.
Oltre all’esplicita, e a volte ridondante violenza, nell’opera della Kane centrale è il punto di vista delle vittime, che hanno difficoltà di espressione. Carl, ad esempio, viene privato dell’uso della lingua dal maniaco maddoctor e numerose sono le immagini di silenzio forzato che lasciano intatta però la possibilità di trasmettere tenerezza in un sanguinante paesaggio di rovine.
Con la quarta opera, Crave, pubblicata con lo pseudonimo di Marie Kelvedon, si avvia la rivalutazione critica della Kane. Rappresentata per la prima volta al Traverse Theatre di Edimburgo il 13 agosto 1998 con la regia di Vicky Featherstone, pur parlando ancora di violenza e sopraffazione, Crave ha una netta impostazione poetica alta e nobile. Struggenti, e forse uniche righe note e citate ‒ anche impropriamente ‒ della drammaturga, le parole che compongono il lungo monologo di A:
«E voglio giocare a nascondino e darti i miei vestiti e dirti che mi piacciono le tue scarpe e sedermi sugli scalini mentre fai il bagno e massaggiarti il collo […] e ridere della tua paranoia e darti nastri che non ascolti e guardare film bellissimi e guardare film orribili e lamentarmi della radio e fotografarti mentre dormi […] e desiderarti la mattina ma lasciarti dormire ancora un po’ e baciarti la schiena e carezzarti la pelle e dirti quanto amo i tuoi capelli i tuoi occhi le tue labbra il tuo collo i tuoi seni il tuo culo il tuo […] e guardare le tue foto e desiderare di averti sempre conosciuta e sentire la tua voce nell’orecchio e sentire la tua pelle sulla mia pelle […] e abbracciarti se sei angosciata e stringerti se stai male e aver voglia di te se sento il tuo odore e darti fastidio quando ti tocco e lamentarmi quando sono con te e lamentarmi quando non sono con te […] e sciogliermi quando sorridi e dissolvermi quando ridi e non capire perché credi che ti rifiuto visto che non ti rifiuto e chiedermi chi sei ma accettarti chiunque tu sia […] e chiederti di sposarmi e dopo che mi hai detto ancora una volta di no continuare a chiedertelo perché anche se credi che non lo voglia davvero io lo voglio veramente fin dalla prima volta che te l’ho chiesto e andare in giro per la città pensando che è vuota senza di te […] e non so come non so come non so come comunicarti qualcosa dell’/assoluto eterno indomabile incondizionato inarrestabile irrazionale razionalissimo costante infinito amore che ho per te».
A che sta abusator, C per child, M per mother e B per boy, sono le quattro voci di cui la Kane si serve per portare sulla scena la parabola delle paure umane, dei nostri desideri più perversi, dell’orrore inconfessabile che si nasconde tra le pieghe di affetti naturali e sinceri. Crave è il bisogno, il desiderio, la voglia, la bramosia, la frenesia, la smania, la fame di, la sete di, la febbre di vivere e di amore, perché, come dice A: «solo l’amore mi può salvare ed è l’amore che mi ha distrutto». Senza voler necessariamente trovare un parallelismo autobiografico con le chiuse e asfissianti pareti domestiche della famiglia dell’autrice, A è un uomo anziano, violento e morboso nei confronti di C, una ragazzina adolescente che non sopporta le sue attenzioni, M è una donna matura che desidera un figlio a tutti i costi da B, giovane ragazzo che la rifiuta. Sono personaggi estremi, borderline, che ricordano per alcuni aspetti la patologica famiglia di Bobbio de I pugni in tasca di Marco Bellocchio (1965), sono soprattutto personaggi che anelano a «ritornare alla vita», come dice M, «felici e in libertà», come chiude C.
L’antologia si conclude con Psicosi delle 4 e 48, rappresentato postumo al Royal Court Theatre Upstairsil 23 giugno 2000. La Kane porta in scena il tema del suicidio con un testo che ha un’esplicita tessitura poetica. Attraverso una vicenda che si frammenta nei riflessi turbati di voci senza corpo che alludono a mille possibili storie lasciate e riprese come in un continuo flusso lirico, la drammaturga mette completamente fuori gioco il concetto di identità tra affermazione e rifiuto di sé e radiografa un progresso distacco dal mondo scandito da affermazioni categoriche, quali «questo non è un mondo in cui ho voglia di vivere […] Ho bisogno di diventare chi sono già e griderò in eterno contro questa incoerenza che mi ha condannata all’inferno […] Posso riempire uno spazio/ riempire una giornata/ ma niente può riempire il vuoto del mio cuore», e da cataloghi di psicofarmaci che ritmano una discesa nell’abisso della follia in un isolamento radicale in cui i rapporti sociali sono solo fonte di sofferenza: «ogni complimento si porta via un pezzo della mia anima».
«per favore aprite le tende»
Rossella Farnese
(www.excursus.org, anno IX, n. 81, marzo 2017)