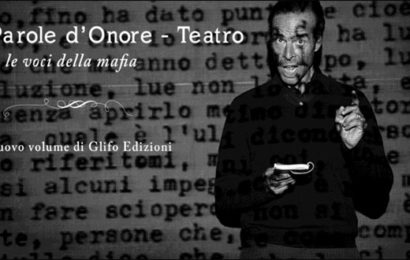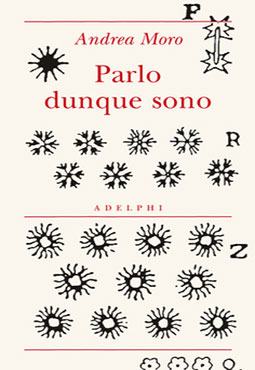 di CHIARA BOSCHI – «Accada quel che deve accadere; io voglio vedere il seme da cui provengo, anche se è umile». Ha inizio con questo passo, tratto dall’Edipo Re di Sofocle, il saggio Parlo dunque sono. Diciassette istantanee sul linguaggio (Adelphi, pp. 104, € 7,00) di Andrea Moro, linguista, neuroscienziato e professore ordinario di Linguistica Generale presso la Scuola Superiore Universitaria di Pavia. Evidente dal principio, quindi, la volontà dell’autore di andare a fondo nel ricercare le origini dell’uomo e di farlo partendo proprio dalla sua facoltà principale, il linguaggio, che «è impossibile che non ci dica qualcosa di noi – a meno di non volerlo – perché sta solo in noi».
di CHIARA BOSCHI – «Accada quel che deve accadere; io voglio vedere il seme da cui provengo, anche se è umile». Ha inizio con questo passo, tratto dall’Edipo Re di Sofocle, il saggio Parlo dunque sono. Diciassette istantanee sul linguaggio (Adelphi, pp. 104, € 7,00) di Andrea Moro, linguista, neuroscienziato e professore ordinario di Linguistica Generale presso la Scuola Superiore Universitaria di Pavia. Evidente dal principio, quindi, la volontà dell’autore di andare a fondo nel ricercare le origini dell’uomo e di farlo partendo proprio dalla sua facoltà principale, il linguaggio, che «è impossibile che non ci dica qualcosa di noi – a meno di non volerlo – perché sta solo in noi».
L’idea di fondo seguita da Moro è che le frasi e le parole «non hanno contenuto in sé, ma se incontrano qualcuno che le ascolta diventano qualcosa», così come i teoremi e le sinfonie, oppure le costellazioni; tutto ciò esiste perché in primis ci siamo noi stessi che parliamo ed ascoltiamo.
«Una scienza che non ci dice niente di noi è inutile, come un album sbagliato» sostiene lo studioso. È questo lo spirito con cui crea il suo album giusto, appunto perché al centro vi siamo noi. Parlo dunque sono è una rassegna di diciassette diapositive sul linguaggio, diciassette contributi importanti alla storia della linguistica e quindi alla nostra storia; il primo apporto alla disciplina è, secondo Moro, quello di Dio, mentre il tassello conclusivo è riservato a Noam Chomsky, padre della Linguistica moderna.
Dio sta al vertice di tutto, è Lui ad averci donato il linguaggio, «caratteristica che ci definisce più di ogni altra» e che «conferma la nostra libertà e la nostra creatività». Moro teorizza la nostra somiglianza con Dio: siamo, come Lui, capaci di dare nomi, e siamo quindi noi a denominare le Sue creature.
Platone è al centro della seconda istantanea; introduce il concetto di harmottein, accordarsi, armonizzare; i nomi, «particelle atomiche del linguaggio», diventano «combinazioni tra atomi», frasi. Ovviamente non tutte le combinazioni danno luogo a strutture possibili: il linguaggio è infatti costituito di un’armonia che non può essere casuale.
Sorge qui una delle questioni principali della linguistica: qual è il rapporto tra le frasi e la realtà? È con Aristotele che nasce la riflessione sulla verità (e falsità) del linguaggio. In quale misura il linguaggio riesce a descrivere efficacemente il reale? Aristotele scardina la proporzione nome sta a verbo come soggetto a predicato, mediante lo studio del verbo “essere”, che appunto è verbo e non predicato, e afferma che si può indagare il linguaggio tramite la logica.
Fornendo nuove diapositive, per mezzo di uno stile sintetico e al tempo stesso ironico, Moro introduce la questione del noto dibattito sulla natura del linguaggio, e cioè quella che vede contrapposte la teoria dell’innatismo linguistico e quella della natura convenzionale del linguaggio. La teoria chomskiana costituisce l’esito di idee antiche perché già espresse a suo tempo da Marco Terenzio Varrone, protagonista della quarta diapositiva: egli sostiene che c’è un qualcosa del linguaggio che sappiamo da soli.
È Ruggero Bacone ad arrivare, con sette secoli d’anticipo, ad una delle grandi acquisizioni della linguistica della seconda metà del Novecento: la grammatica è una sola in tutte le lingue, anche se accidentalmente possono esserci delle variazioni. Con Cartesio si inizia a parlare della derivazione cerebrale delle strutture linguistiche. Si può dire con facilità che gli animali, poiché legano pensiero e comunicazione, possiedano un linguaggio. Ma a proposito di struttura del linguaggio, gli animali non possiedono la sintassi ed è proprio questa la particolarità del nostro codice che, così ricorsivo e selettivo, può essere espresso solo da un cervello umano, sulla base di modalità funzionali neurobiologiche.
Nella settima diapositiva, con Antoine Arnauld e Claude Lancelot vengono messi in evidenza due aspetti molto interessanti del linguaggio, opposti ma al tempo stesso in equilibrio fra di loro: la ricorsività e la ridondanza. Moro include nel suo album anche sir William Jones poiché esprime un concetto interessante: la somiglianza tra le lingue è un dato oggettivo che diviene comprensibile solo se si apre la strada alla ricostruzione di ciò che c’era prima e che non c’è più, sulla base di ciò che c’è ora. Jones sente perciò la necessità di studiare i volgari, oltre alle lingue ufficiali.
A metà Ottocento, con Hermann Osthoff e Karl Brugmann si compie un passo decisivo: la linguistica viene per la prima volta strappata al dominio esclusivo della logica e del ragionamento formale e al suo centro viene posta la nozione di legge. Sostenere che il linguaggio obbedisca a leggi, seppur di tipo fonetico, ha del sorprendente, se si considera l’epoca. L’introduzione di tale nozione ha lasciato un’eredità inestimabile e il nostro linguaggio resiste ancora saldamente nel suo ruolo di scandalo costante: «è costruito sulla carne e matematico nelle regole».
Con l’affermazione di Ferdinand de Saussure che nella lingua non vi sono che differenze, prende corpo l’idea di uno strutturalismo linguistico: le intuizioni precedenti vengono formalizzate scientificamente fino a giungere a considerare che «ogni proprietà definita per un elemento è definita anche per tutti gli altri». Con Bertrand Russell, matematico e logico, riappare il verbo “essere”, «questione omerica della linguistica». Egli vuole neutralizzare la crepa che si era aperta nell’impresa di fondare tutta la matematica sulla logica e, per far ciò, si era servito di tale verbo. È per lui unadisgrazia che esso esprima al contempo predicazione e identità tra due individui. Ma un linguista smonta subito questa preoccupazione perché non può essere trattato come un comune verbo transitivo. Quella crepa, quelmostro, come la chiama Moro, è crepato quindi da solo.
Importante è anche il contributo di Martin Joos il quale, sostenendo che le lingue possono differire le une dalle altre senza limiti e in modi imprevedibili, è vittima di un errore. L’esistenza di un progetto soggiacente alla complessità delle lingue renderebbe Babele soltanto una distorsione ottica. È nell’album giusto anche Roman Jakobson, che pone nuovamente al centro dell’analisi linguistica la nozione di sintassi: essa sembra non degenerare nella specie, anche se i nuovi nati sembrano non possederla inizialmente. Si può quindi parlare di precondizionamento? Moro sostiene che non esistono mutanti umani senza linguaggio.
Joseph Harold Greenberg è in grado di fornire un’indicazione metodologica considerevole: la scienza può fare passi enormi anche se non pretende di spiegare e si limita adescrivere. È così che appare la linguistica oggi: descrive, tramite la comparazione, la presenza di strutture invarianti e di regole precise che creano quei rapporti armonici tra le parti e il tutto, che costituiscono il linguaggio.
Siamo giunti a metà Novecento: Eric Heinz Lenneberg sostiene che una ricerca biologica sul linguaggio appare paradossale dal momento che viene ammesso che le lingue consistono di convenzioni culturali di natura arbitraria. Si è di fatto arrivati a censurare gli studi sui fondamenti biologici del linguaggio, ma quest’ultimo non è una convenzione culturale di natura arbitraria, sono le lingue specifiche ad esserlo, in particolare la sintassi. È questa la vera novità rispetto alla ricerca di tradizione ottocentesca.
La scoperta straordinaria di Niels Jerne è che, quando una frase ci entra nel cervello, il sistema che la decifra non si forma del tutto come reazione alla frase, ma vi è unrepertorio, precedente all’esperienza, sul quale il cervello, quando entra in contatto con un codice linguistico, può contare. È questa, in nuce, la teoria della cosiddetta grammatica universale.
Il collegamento con Chomsky diviene a questo punto inevitabile. La sua teoria è riassumibile in questa affascinante massima: «il linguaggio è più simile a un fiocco di neve che al collo di una giraffa». Il linguaggio, e quindi la sintassi, o c’è tutto o non c’è affatto, deve manifestarsi in blocco. La sua configurazione non sottostà alle stesse leggi biologiche che hanno generato la struttura neurobiologica che la esprime, cioè il cervello. Il linguaggio è pertanto affine al fiocco di neve: «ogni fiocco di neve, con le sue numerosissime ma non infinite variazioni microscopiche, è in un certo senso, una tra le soluzioni di una complessa equazione fisica: la sua struttura dunque è la risposta pressoché istantanea alle condizioni di temperatura, gravità, pressione, quantità e purezza dell’acqua». Il cervello, invece, sorge da un percorso diverso, tutt’altro che istantaneo, dove contano anche altre variabili, come il caso e la storia; lo stesso vale per il collo della giraffa.
Leggendo l’istantanea dedicata a Chomsky sembra quasi che l’autore condivida la medesima posizione; in realtà egli si limita ad osservare come il cervello umano costituisca certamente una singolarità nel panorama biologico. Lo testimonia la combinazione di due tratti indipendenti: il fatto che la struttura ricorsiva del linguaggio umano non abbia equivalenti in altre specie e il fatto che questa struttura ricorsiva sia espressione del cervello, l’unica possibile quando si tratta di linguaggio, non una convenzione culturale di natura arbitraria.
Giunti a questo punto Moro tira le somme e sostiene che molto altro ancora si sarebbe potuto dire dovendo ammettere che l’album non è completo ma a questo punto la domanda che si pone, e con la quale ci lascia, è se un album sul linguaggio potrà mai esserlo perché «in certi momenti il linguaggio sembra stare alla nostra comprensione come la tartaruga alla presa di Achille: ogni volta che ci avviciniamo, sembra allontanarsi di un poco».
Un testo stimolante. Da un lato conciso e tecnico, come è consuetudine per un volume scientifico ma, al tempo stesso, denso e corposo, ricco e consistente, nonostante la sua brevità. Certamente suggestivo, a volte sorprendente e capace di far sentire il lettore, man mano che le pagine scorrono, parte portante di quel noi che l’autore tanto ama mettere in rilievo.
Chiara Boschi
(www.excursus.org, anno VII, n. 72, ottobre-novembre 2015)