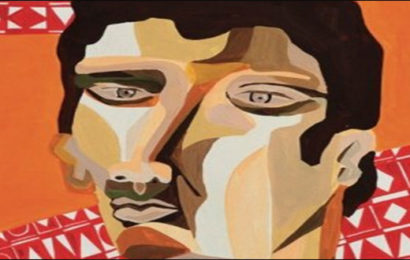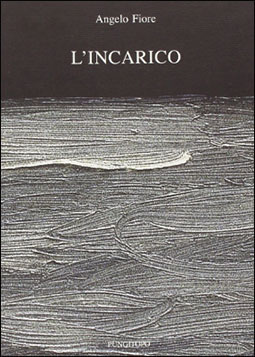 di MELINA MELE – Improduttivo, incapace, fallito. Sin dalle prime pagine del terzo romanzo di Angelo Fiore, L’incarico (1970), la figura del protagonista, Giovanni Salfi, corrisponde a quella di un impiegatuccio grigio e negligente, un «esperto nel danneggiare la società e soprattutto questo ufficio», come lamentano i colleghi. Molto presto, tuttavia, la sua esistenza letargica da burocrate qualunque subirà una svolta inaspettata; a determinarla sarà l’incontro con il collega Ambrogio Pravatà, uomo attivo, furbo e truffatore, che giungerà ad affidargli il compito insolito di «collaboratore temporaneo», ossia, di suo sostituto nel ruolo di capofamiglia durante la sua reclusione in carcere. Nell’assegnare questo incarico, Pravatà si pone come artefice di un nuovo destino per Salfi, di una nuova possibilità di significato nella vuota esistenza di un uomo, la cui vita, come egli spiega alla moglie: «non giova, ma può servire agli altri».
di MELINA MELE – Improduttivo, incapace, fallito. Sin dalle prime pagine del terzo romanzo di Angelo Fiore, L’incarico (1970), la figura del protagonista, Giovanni Salfi, corrisponde a quella di un impiegatuccio grigio e negligente, un «esperto nel danneggiare la società e soprattutto questo ufficio», come lamentano i colleghi. Molto presto, tuttavia, la sua esistenza letargica da burocrate qualunque subirà una svolta inaspettata; a determinarla sarà l’incontro con il collega Ambrogio Pravatà, uomo attivo, furbo e truffatore, che giungerà ad affidargli il compito insolito di «collaboratore temporaneo», ossia, di suo sostituto nel ruolo di capofamiglia durante la sua reclusione in carcere. Nell’assegnare questo incarico, Pravatà si pone come artefice di un nuovo destino per Salfi, di una nuova possibilità di significato nella vuota esistenza di un uomo, la cui vita, come egli spiega alla moglie: «non giova, ma può servire agli altri».
Presto prende forma, dunque, quella duplicità della nuova responsabilità di Giovanni, su cui l’autore pone l’attenzione sin dalla scelta del titolo, L’incarico: il protagonista, vivendo all’interno di siffatto nucleo familiare, sarà spronato a cogliere l’occasione per riqualificarsi come individuo, collocandosi in modo definito ed attivo nella realtà sociale. La doppia valenza, letterale e metaforica, del compito si esplica chiaramente in un dialogo tra i due personaggi:
«Ho fede in te. Gli altri mi hanno deluso. […] Volevi introdurti nel mio mondo, nella mia famiglia; e conoscere Dora. Io ti ho assecondato, ti ho dato il mezzo di …».
«È una prova».
«Senza di me, che faresti? – Pravatà domandò, indulgente; ma con un po’ d’ansia. – Senza i miei errori non avresti nulla da fare. Ti ho reso un servigio; ti ho messo in grado di provare, di vivere. Per te sono come un mago benefico. Che farai? Come agirai? Questo voglio sapere. In che modo amministrerai la vita che ti ho affidata? Sei una specie di Lazzaro […]. Ti addormentavi, eri come paralizzato; senza di me, non avresti una vita materiale. […] Voglio sapere, ardo di curiosità. Ora anche tu sei nel mondo, vi appartieni».
«Tu mi hai collocato nel mondo».
«È così» Ambrogio disse.
E così, nonostante il suo temperamento solitario (si vocifera in ufficio che si prepari alla vita religiosa) e la sua natura insondabile, caratterizzata dall’avvicendarsi instabile di «modi di essere contrastanti e opposti», Salfi viene introdotto nel mondo apparentemente rassicurante di una famiglia borghese, che, tuttavia, cela sotto la superficie una profonda artificialità e una meschinità fatta di freddezza, di sospetti, di segreti e di allusioni inquietanti. Su tale commistione di sospetto e reciproca dipendenza, di diffidenza e riguardo si sviluppano i legami interni alla famiglia, i quali, oltre a sconfinare il limite del lecito, rivelano l’incolmabile distanza emotiva che segna i rapporti umani.
Dal momento in cui il protagonista si insinua in casa, la sua incapacità di accedere alla sfera delle percezioni e dei sentimenti si acuisce, divenendo causa e, al tempo stesso, conseguenza di una rovinosa e irreparabile perdita dell’io. Una volta frantumata tale integrità, per Salfi l’ambiente familiare si trasforma nel luogo in cui potere soddisfare i suoi bisogni sessuali depravati. Egli persegue liberamente il suo demone interiore, deludendo la speranza di conferire un senso alla propria esistenza, ossia, compiere quella metamorfosi da ‘essere inutile’ a punto di riferimento, di cui lo ha incaricato Ambrogio. Lontane dall’immagine rassicurante del focolare, le dinamiche familiari diventano manifestazione del lato oscuro dell’essere umano, della bassezza sregolata non più imprigionata nell’inconscio, ma cui l’uomo dà libero sfogo nella quotidianità e tra le pareti domestiche, agendo con distacco, senza la minima consapevolezza del male:
Salfi aveva la mente limpida; nessun turbamento, solo un lieve tremito.
“Eppure, ho fatto quei gesti. Ma, che cosa sentivo?”.
Non ricordava, era difficile rivivere quegli attimi. “Forse non sentivo nulla”.
Com’era giunto a quell’atto, a cui non aveva la disposizione né la voglia?
Si ricordava dell’atto o degli atti, ma non delle sensazioni relative; e non ritrovava l’impulso e i moti connessi.
La fuga dai Pravatà, seguendo la risoluzione di dedicarsi alla vita religiosa, rappresenta l’ultimo tentativo per il protagonista di ricucire il suo io lacerato, di ridefinirsi attraverso l’abnegazione di sé nella vita spirituale. Ma poiché il proposito di Giovanni non presuppone un forte sentimento di fede, né egli è provvisto della volontà necessaria per negarsi alle minacce del suo stesso inconscio, anche questo definitivo banco di prova segna l’ennesimo smacco nella vita del protagonista, sancendo l’irreversibile perdita della coscienza, il senso della «fine della sua interiorità, della sua forza morale». In continuità con le prove precedenti, Fiore propone nelle pagine del suo romanzo la vicenda esemplare di un fallimento.
L’esistenza di Giovanni Salfi, similmente a quella dei protagonisti del Supplente (1964) e del Lavoratore (1967), si conduce all’insegna della incongruenza tra la volontà di agire e la consapevolezza dell’insuccesso. Inadatto a perseguire qualsiasi obiettivo, il protagonista dell’Incarico resta legato ad una condizione di marginalità sociale, imprigionato nel sottosuolo esistenziale dalla sua invalidità di spirito, fino a perdere se stesso nelle sue più intime aberrazioni. Anche in questa opera, pertanto, si ritrova il tema ricorrente e centrale della poetica dell’autore palermitano, che, per tale motivo, è stato definito da Geno Pampaloni «monotematico e iterativo»: l’ossessione per il fallimento, per quel mondo turbato ed angosciante popolato da disorientate coscienze che, nella ricerca di un senso che sostanzi la loro vita, si infrangono irrimediabilmente.
Eppure, L’incarico non si limita ad inserirsi all’interno del corpus fioriano, riprendendone contenuti e forme, bensì presenta le spie di un’evoluzione nella poetica dello scrittore rispetto alla raccolta degli esordi, Un caso di coscienza (1963), e ai primi romanzi: un passo in avanti, ma sarebbe più corretto dire una discesa, verso un pessimismo più inquietante, perché freddo, privo di rammarico, e perché si fonde alla quotidianità, trasformandola in squallido scenario di un orrore che non sconvolge. Se, ad esempio, Attilio Forra, protagonista del Supplente, concretizza le depravazioni del suo inconscio nelle proiezioni grottesche degli Invisibili, Giovanni Salfi supera il confine dell’immaginazione, trasformando le sue morbose fantasie sessuali in realtà.
Tramite l’indifferenza e la distanza che muovono il protagonista durante questi atti, come anche la dimenticanza che sopraggiunge dopo averli compiuti, lo scrittore dà una rappresentazione della corruttela morale dell’uomo per mezzo delle vicissitudini degradanti del corpo, ma soprattutto, delinea la sua personale visione dell’uomo del Novecento, un individuo la cui condizione ontologica non è solo l’indolenza morale e l’abulia esistenziale, ma persino l’intorpidimento psicofisico.
Infatti, se con L’incarico, da una parte, l’autore ribadisce l’impossibilità per l’uomo di accedere alla sfera dei significati, di prendere posizione nella vita («vogliono che io assuma la responsabilità della vita e dia un fine a tutti gli atti»), dall’altra, questa condizione del guardarsi vivere viene ulteriormente complicata dalla sua incapacità di percepire se stesso («non percepisco né sento, ma vivo»), di riconoscere le proprie sensazioni ed emozioni, per quanto incisive. Persino la memoria delle percezioni è inaccessibile ormai:
A un tratto gli parve di non aver commesso quei gesti:
“Ne ho udito parlare, è il ricordo di una cosa avvenuta ad altri […]”.
L’animo diventava placido.
“La memoria mi inganna” egli si disse.
Le scelte formali concorrono a sottolineare il nuovo torpore percettivo che atrofizza il protagonista, riflettendolo nell’uso di uno stile privo della vis aggressiva, grottesca e a tratti espressionistica tipica del Supplente. Il motivo delle sesso, che accomuna entrambe le opere e che ne è il campo sensoriale privilegiato, viene declinato in modo meno esplicito nell’Incarico, tramite l’uso di lemmi vaghi ed eufemistici. Se, nel Supplente, il lessico si adegua incensuratamente alle turpitudini immaginarie della psiche di Forra, sviluppandosi in chiare definizioni anatomiche, in descrizioni oscene e termini espliciti, in questo romanzo, dove le fantasie si convertono in realtà, il manifesto si trasforma in implicito, il coinvolto in distanziato. Così, la “penetrazione” (pratica costante degli Invisibili) diventa l’“abbraccio”. Non esplodendo mai in un vocabolario scabroso, la perversione resta sottintesa e velata, ma se ne avverte la tensione, se ne intuiscono gli inquietanti risvolti e palesa la distanza dell’uomo dalla sfera corporale e morale.
Questa nuova realizzazione formale convive nella pagina con le peculiarità tipiche dello stile fioriano, che rispecchia il pensiero grande ed irrisolto dei personaggi. Esso esaspera la tortuosità dell’indagine interiore attraverso l’impiego di astrazioni metafisiche e aforistiche, le quali producono disorientamento nel lettore (che è, d’altra parte, lo stesso di Giovanni).
Tale difficoltà interpretativa è causata dalla volontà dell’autore di concentrare la carica concettuale e, al tempo stesso, intensificare la scissione dell’io di Salfi, rappresentando la compresenza di spinte opposte della sua natura con l’uso frequente di termini antitetici, come possiamo vedere nei seguenti passi, entrambi riferiti al protagonista:
Ti muovi nel medesimo luogo, t’illudi di progredire. E ti decidi alla rinuncia. In fondo, progredire è come rinunziare.
Sapevo che mentivi; ma nel mentire sei onesto. Mentire sempre o per breve tempo non cambia nulla.
Da questi due esempi, si nota chiaramente come la struttura sintattica sia tesa ad esprimere il progredire inceppato delle elucubrazioni dei personaggi e sia articolata in un periodare segnato dall’uso insolito della punteggiatura, che spezzetta l’andamento altrimenti scorrevole della frase per creare pause inaspettate e azzerare ogni gerarchia narrativa, seguendo la logica dell’inconscio. Anche l’elaborazione sintattica manifesta la volontà dello scrittore di esprimere la lotta interiore tra il bisogno di trovare un principio fondante dell’esistenza, di possederlo e di saperlo comunicare, e la natura invalidante dell’animo, quella tendenza incontrollabile che conduce i personaggi verso il fallimento.
In tal modo, l’Incarico contribuisce a declinare ancora più originalmente la poetica dello scrittore, ponendo all’attenzione del lettore un male di vivere declassato, tinto di squallore, di buffonesca mediocrità e di un pessimismo che è quasi fascino e lusinga del fallimento. In seguito alla perdita definitiva delle corrispondenze con il mondo e con il proprio io, il protagonista del romanzo, come uomo del Novecento, appare come condannato a vivere «dimentico di sé».
Melina Mele
Su gentile concessione della Pungitopo Editrice, pubblichiamo l’Introduzione di Melina Mele al romanzo di Angelo Fiore L’incarico (pp. 192, € 17,00).
(www.excursus.org, anno VII, n. 69, aprile 2015)