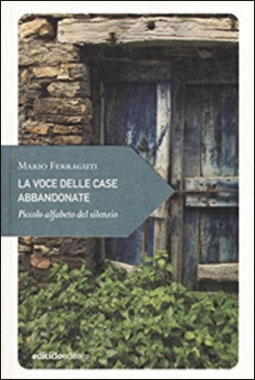 di MICHELE CAVEJARI – «Le case abbandonate hanno i pavimenti lisci di passi, a forza di passare e ripassare, e ci sono giorni in cui quei passi li fanno risentire tutti, uno a uno, ognuno con il suo suono unico, diverso; basta trovare il bicchiere giusto dentro la credenza, uno di quelli semplici per l’acqua, metterlo sul pavimento e appoggiare l’orecchio sul vuoto come fosse una conchiglia».Così Mario Ferraguti, nel breve saggio intitolato La voce delle case abbandonate. Piccolo alfabeto del silenzio (ediciclo, pp. 96, € 8,50).
di MICHELE CAVEJARI – «Le case abbandonate hanno i pavimenti lisci di passi, a forza di passare e ripassare, e ci sono giorni in cui quei passi li fanno risentire tutti, uno a uno, ognuno con il suo suono unico, diverso; basta trovare il bicchiere giusto dentro la credenza, uno di quelli semplici per l’acqua, metterlo sul pavimento e appoggiare l’orecchio sul vuoto come fosse una conchiglia».Così Mario Ferraguti, nel breve saggio intitolato La voce delle case abbandonate. Piccolo alfabeto del silenzio (ediciclo, pp. 96, € 8,50).
Che il silenzio sia enormemente eloquente, una voce primitiva e carica di pathos, lo sa bene il cercatore di case abbandonate. Nel silenzio di un’abitazione, egli reperisce tutta la profondità e il significato del genius loci caro ai latini. Ad ascoltare bene, s’imbatte nell’eco di mille voci, tante risa e qualche pianto. A guardare bene nella pancia del buio, e cioè oltre l’uscio, emerge un singolare mosaico di tracce e suggestioni; testamento distratto di chi è già passato oltre, ma per gli stessi silenzi.
Riporta l’autore: «impronte ben nitide di cani, gatti, faine e il piede scalzo e leggero di un bambino. Hanno lasciato un segno, qualcosa al volo della loro vita, l’hanno lasciato per sbaglio, senza rendersi conto che sarebbe stata la cosa che sarebbe durata più a lungo».
Il libro di Mario Ferraguti si ritaglia un posto di primo piano nella letteratura del silenzio e della pietra. Restituisce vita e protagonismo assoluto a ciò che comunemente liquidiamo come antonomastica imago mortis. Il suo è perciò un dialogo intimo coi luoghi decaduti, tappa dopo tappa, dalla montagna al mare. Molto più che cronaca, molto più che reportage. La veste ufficiale è quella del saggio, ma lo stile ammicca compiacente al dominio della poesia. Ne scaturiscono immagini, affatto descrizioni; antologie, e non almanacchi di cose perdute.
Già, ma perché tradurre con partecipazione le memorie delle case abbandonate? Che cosa spinge a condividere quel mistero, a sbobinare lunghe meditazioni col silenzio?
Si racconta di porte sfondate (di bocche spalancate e mute) per liberare voci, preziosi frammenti di storia. Lo si fa per restituire un ruolo (e un tempo presente) a scheletri che la storia ha messo definitivamente da parte. Talvolta, si narra di case abbandonate per lavare via quel senso di colpa che l’abbandono tatua sull’anima del forestiero, sul cuore di colui che cammina dentro e attraverso le macerie.
Senza dubbio, chi – come Mario Ferraguti – si è occupato di case abbandonate compone letteratura di salvamento. La “penna” salva, poiché dentro l’osso del muro, dietro fruscianti selve d’ortica, qualcosa resiste. A parlare, sono piccole-grandi presenze, molto più che forme: testimonianze, residuali forme di vita, compagne d’esistenza di chi abitava stanze oggi ricoperte dalla polvere e dalla tela dei ragni. Tutte cose che hanno atteso lungamente un orecchio a cui aprirsi: testimoni mansueti, talvolta ammonitori, talaltra fonti d’inquietudine e rispetto.
Inizialmente, è lo stesso Mario Ferraguti ad ammetterlo: l’esploratore si sente preda della paura e dell’imbarazzo. Le cose, scrive, aggrediscono «come cani da guardia alla casa» e paiono voler scacciare«uno che non c’entra niente o forse è arrivato troppo tardi». Poi però, la compassione, mirabile voce, educanda figlia del rispetto, porta il visitatore ad accarezzare i calcinacci. E se le case si fidano, le cose prendono la parola, muovono una muta interpellanza all’archeologo dell’abbandono. Dicono: «scegli se liberarci dall’oblio, oppure se lasciarci nel crepuscolo in cui siamo precipitate».
All’autore, in merito, accade di rispondere accettando la responsabilità del furto. Mario Ferraguti si sente in dovere di portare via qualcosa. Diventa così l’esploratore che penetra l’abisso del tempo e tenta di riemergere serbando con sé un frammento di passato, per consegnarlo alla luce del presente. «Sì lo so» ammette con consapevolezza «il verbo sarebbe rubare […]; ma cercare e poi prendere piccole e grandi cose che si trovano nelle case che stanno per crollare non so se è uguale a rubare, lo vedo più vicino al senso di salvare».
La voce narrante sceglie comunque di darsi delle regole pur di allontanare l’onta del ladrocinio. Impara a non forzare la volontà della casa,a non farle saltare i denti pur di penetrarla, a ponderare ogni passo, a dormirci dentro, a non inquinare il tempo della pietra con il tempo degli uomini: «un tempo veloce e violento» che introduce «la fretta e la necessità a rompere l’incanto». Soprattutto nel corso dei suoi progressivi esercizi di confidenza con le case abbandonate (dieci in totale), Mario Ferraguti impara a non sottrarre mai dalle stanze oggetti troppo personali, i quali presto o tardi «diventano fastidiosi», esalando il fantasma di colui che li possedeva.
L’abbandono, questo il messaggio dell’autore, ha una voce. Le case e i paesi non tacciono per sempre una volta che le persone se ne sono andate. Le case resistono e serbano testimonianze: serbano sconvolgenti radiografie all’anima degli assenti e con la loro voce sirenica attraggono l’esploratore, il rabdomante in cerca di memorie; invitano a percepire la tensione alla custodia, alla cura, alla salvaguardia.
Ora, per il lettore che fosse interessato a compiere un percorso letterario attorno al tema delle forme plastiche della memoria, ovvero della fisicità del sentimento, e dunque del corpo della casa come corpo vivente, può essere interessante accostare al saggio di Mario Ferraguti i romanzi di Mauro Corona e Julio Llamazares.
Corona – ne I fantasmi di pietra – racconta di Erto. Porge l’orecchio a una geografia insultata dalla storia, braccata dalla solitudine. Il suo è un paese deserto, quattro vie di crolli. Come lo scrittore si sente in dovere di salvare qualche oggetto, per sottrarlo alla polvere. Aggiustare il braccio di un’altalena, ad esempio: un gesto assoluto, d’irriducibile speranza.
Complementare al realismo onirico dello scrittore friulano, abbiamo poi La pioggia gialla di Llamazares; pagine caustiche, corrosive, in grado di proiettare sulla retina un vero e proprio incubo. Dal sogno al vaneggiamento il passo è breve. Quello del protagonista Andrés de Casas Sosas, infatti, altro non è che il delirio allucinato dell’ultimo abitante di un paese dei Pirenei aragonesi. È lui lo spettro questa volta, il fantasma, l’anomalia in un mondo che si spegne e scolorisce(ma pur sopravvive).
Leggere di case abbandonate, insomma, non significa affatto accedere a topografie nascoste, o peggio, curiosare nelle vite degli altri. Al contrario, libri come questi ci aiutano ad abitare meglio il nostro tempo;ci esortano a sottrarre la memoria dai crolli, a tutelare la ricchezza di luoghi altrimenti destinati all’estinzione.
Scrivere di case abbandonate non è che il pretesto per parlare di uomini, saperi e tradizioni;il punto di partenza per rimboccarsi le maniche. Al pari, ristrutturare un borgo antico(per ripopolarlo) diviene molto più che un atto di mero bricolage, una concessione alla nostalgia o alle fantasie bucoliche…
Salviamo la pietra e daremo una possibilità alla carne.
Michele Cavejari
(www.excursus.org, anno IX, n. 85, agosto 2017)









