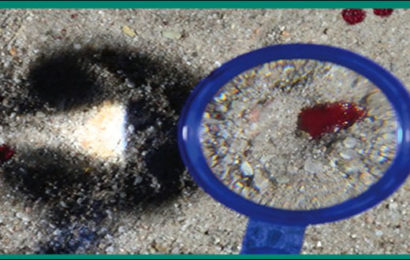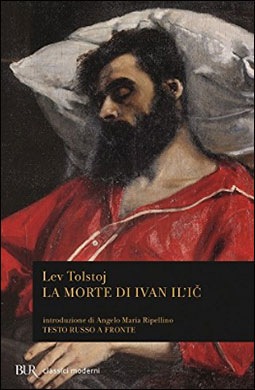 di VALERIA LO CICERO – C’è un uomo che sta per morire di cancro a San Pietroburgo; la sua è una condizione rimasta celata da una coperta di semi-incoscienza, che non l’ha però protetto abbastanza dall’egoismo dell’Altro e che l’ha reso più cupo della notte. È un uomo che «era una via di mezzo», con una decorosa casa, un rispettabile lavoro, una famiglia impeccabile e amici incorruttibili. Il lettore sappia però diffidare della perfezione.
di VALERIA LO CICERO – C’è un uomo che sta per morire di cancro a San Pietroburgo; la sua è una condizione rimasta celata da una coperta di semi-incoscienza, che non l’ha però protetto abbastanza dall’egoismo dell’Altro e che l’ha reso più cupo della notte. È un uomo che «era una via di mezzo», con una decorosa casa, un rispettabile lavoro, una famiglia impeccabile e amici incorruttibili. Il lettore sappia però diffidare della perfezione.
Siamo tra le pagine di un racconto dove la dimensione della morte e quella della vita sembrano compenetrarsi (La morte di Ivan Il’ič di Lev N. Tolstoj, Introduzione di Angelo Maria Ripellino, traduzione di Erica Kein, Bur, pp. 96, € 5,90) nell’accogliere il lettore sullo sfondo di una grottesca contemplazione funebre, dove a mancare è esattamente la percezione di ciò che di valore si può perdere e, a dominare, strati di polvere su tutte le cose, siano essi oggetti, decorosi comportamenti, o volti pressoché umani: «Cominciò la funzione – candele, lamento, incenso, lacrime, singhiozzi. Petr Ivanovic se ne stava in piedi accigliato e si guardava le scarpe».
In un viaggio a ritroso, pieno di oscillazioni, il lettore accompagna Ivan Il’ič e, come lui, tentenna in uno stato di semi-incoscienza, accorgendosi in ritardo di quante cose possano morire tutte insieme, senza farsi spazio e senza il tempo di rifletterci sopra, perché ci sono cose umane più importanti che ci scorrono davanti. È già data,ma è quasi irraggiungibile, l’esatta inquadratura del protagonista, che si muove tra perdite e conquiste poi smarrite nuovamente; sceglie ogni convenzione per salvarsi dalle scelte, in un percorso esistenziale che appare predeterminato da quel momento in cui «partì per la provincia a occupare il posto trovatogli dal padre, con incarichi speciali presso il governatore»; si opera invece, in realtà, una rivoluzione, taciuta ma autentica.
Il morituro Ivan Il’ič, nel suo tragitto, è accompagnato da un alone cupo che, al suo passaggio, sembra mimare un effetto dissolvenza che annienta ogni pseudo-protezione data dal decoro. Egli si ritrova circoscritto al cerchio della solitudine: è stata rimossa l’ultima ombra di empatia con la moglie e non è mai stato contemplato il più sottile filo d’affetto per il personaggio-sagoma della figlia «forte, sana, visibilmente innamorata e infastidita dalla malattia, dalle sofferenze, dalla morte che ostacolavano la sua felicità», della quale non si può dire che sia tale e quale al padre, insomma. Ma ecco che arriva qualcuno a spezzare questo cerchio che racchiude il protagonista, che il lettore saprà riconoscere per il suo preservarsi incontaminato dalla coltre di parvenza, disinteressato dal decoro.
È l’unico che porta dentro di sé rispetto e buona compassione, ed è la figura che muove quella timida rivoluzione in Ivan Il’ič, tra le pagine di questo racconto silenzioso. C’è come una tenue pioggerellina che bagna il viale nel quale il protagonista si immette al termine del suo viaggio, e che appare come una galleria piena di quadri della vita vissuta. È qui che ci appare piccolo, spoglio del suo decoro, smarritosi alla ricerca della compassione altrui e con l’avanzare della paura della morte. Non c’è medico rinomato, né omeopata con cure alternative, né rigida alimentazione che possa fermare la degenerazione di quell’intestino cieco che se ne va a marcire. Solo l’immaginazione può risanarlo, rimetterlo a posto riassorbendone il male. Forse si può non morire.
E si scorge, infine, in lontananza, un angolo mai apparso prima, una nascita. Qui vive la luce dell’alterità umana: la stessa che avrà ritrovato il più attento lettore.
Valeria Lo Cicero
(www.excursus.org, anno IX, n. 80, febbraio 2017)