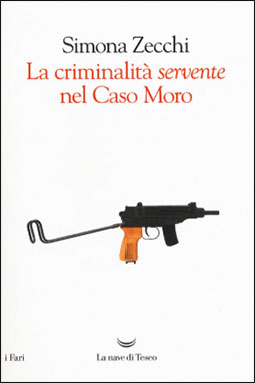 di GIUSEPPE LICANDRO – Il 16 marzo 1978 era previsto il voto di fiducia della Camera dei Deputati per l’insediamento del IV governo presieduto da Giulio Andreotti. Questi contava di ottenere l’appoggio esterno del Partito Comunista Italiano, a coronamento del “compromesso storico” voluto dal suo segretario Enrico Berlinguer. Simona Zecchi
di GIUSEPPE LICANDRO – Il 16 marzo 1978 era previsto il voto di fiducia della Camera dei Deputati per l’insediamento del IV governo presieduto da Giulio Andreotti. Questi contava di ottenere l’appoggio esterno del Partito Comunista Italiano, a coronamento del “compromesso storico” voluto dal suo segretario Enrico Berlinguer. Simona Zecchi
Poco prima delle 9:00, il presidente della Dc Aldo Moro uscì dalla propria residenza romana per recarsi a Palazzo Montecitorio e, insieme ai carabinieri Domenico Ricci e Oreste Leonardi, salì su una Fiat 130, scortata da un’Alfetta su cui presero posto tre poliziotti (Raffaele Iozzino, Giulio Rivera, Francesco Zizzi).
Lungo via Fani – all’incrocio con via Stresa – la macchina presidenziale fu bloccata da una Fiat 128, guidata da Mario Moretti, capo della colonna romana delle Brigate Rosse. Dalle fioriere dell’antistante Bar Olivetti sbucarono quattro brigatisti camuffati da avieri dell’Alitalia (Franco Bonisoli, Raffaele Fiore, Prospero Gallinari, Valerio Morucci) che in pochi minuti spararono 91 colpi, trucidando i cinque uomini della scorta di Moro.
Un testimone oculare dell’agguato, l’ingegner Alessandro Marini, fu preso di mira da due misteriosi giovani in sella a una moto Honda, che non appartenevano alle Br e sulla cui identità non fu mai fatta chiarezza. Contro Marini venne sparata una raffica di mitra che frantumò il parabrezza del suo motorino, senza però ferirlo. Simona Zecchi
Il presidente democristiano fu rapito e trasferito su una Fiat 132, per essere poi condotto − secondo la dubbia ricostruzione dei fatti fornita in seguito dai brigatisti – nel covo di Via Montalcini, dove sarebbe rimasto fino all’esecuzione, avvenuta il 9 maggio seguente.
La morte di Moro, oltre a metter in crisi il compromesso storico, lasciò un lungo strascico di sospetti e segreti, su cui hanno tentato di fare luce cinque processi e due Commissioni parlamentari d’inchiesta, l’ultima delle quali ha chiuso i propri lavori nel dicembre 2017, sconfessando il “memoriale” scritto in carcere nel 1986 da Morucci.
Il ruolo della criminalità nel Caso Moro
I tanti misteri irrisolti del rapimento e della morte dello statista pugliese sono stati affrontati nell’interessante volume La criminalità servente nel Caso Moro (La nave di Teseo, pp. 294, € 19,00) dalla giornalista Simona Zecchi, che ha ricostruito gli oscuri rapporti intercorsi tra i terroristi rossi e le principali organizzazioni criminali attive in Italia negli anni Settanta dello scorso secolo.
L’autrice ha fatto ricorso allo schema giornalistico della “piramide rovesciata” che rende evidente fin dall’inizio la notizia principale da comunicare ai lettori per poi articolare la tesi di partenza, illustrandone i dettagli e i nessi causali. Simona Zecchi
Secondo Simona Zecchi, il lavoro svolto dall’ultima Commissione parlamentare d’inchiesta tra il 2014 e il 2017 – sebbene «non privo di novità e di passi avanti» – non è servito a chiarire del tutto i retroscena dell’affaire Moro, perché non ha indagato a fondo sulla presenza della «criminalità organizzata nelle sue componenti fondanti di quegli anni» e sul ruolo “servente” che essa avrebbe svolto nei confronti dei “poteri forti”.
La versione dei fatti fornita dai brigatisti presenta evidenti falle e contraddizioni. Nel corso del quarto processo Moro, la Corte d’Assise di Roma ha dimostrato che a sparare furono sei o sette armi «contro le quattro indicate in seguito dai brigatisti», così come una recente sentenza della Procura Generale romana ha stabilito che i protagonisti dell’agguato «furono molti di più dei nove o dodici brigatisti indicati da Valerio Morucci».
La novità più importante emersa recentemente, tuttavia, è la foto – scattata in via Fani il 16 marzo 1978 dal carrozziere Gherardo Nucci – che è stata pubblicata nel 2016 dal quotidiano Il Messaggero, nella quale si distingue il boss della ‘ndrangheta Antonio Nirta, pochi minuti dopo la strage. Alle sue spalle s’intravedono le saracinesche del Bar Olivetti, il cui proprietario fu segnalato dalla polizia come «partecipe di una rete di interessi criminali legati al traffico internazionale di armi».
Simona Zecchi inserisce nel libro anche una seconda foto – scattata lo stesso giorno, sempre in via Fani, da Gennaro Gualerzi – nella quale si riconosce Giustino De Vuono, ex volontario della Legione Straniera, nonché «criminale e aspirante ’ndranghetista mai affiliato ufficialmente».
Pietro Modiano, testimone della II Commissione “Moro”, ha riferito che don Cesare Curioni (a lungo capo dei cappellani carcerari) era convinto che, il 9 maggio successivo, «a uccidere il presidente della Dc fosse stato proprio Giustino De Vuono», a differenza di quanto dichiarato da Moretti, che si autoaccusò del delitto e che – secondo lo ‘ndranghetista pentito Francesco Fonti – ricevette soldi in carcere per nascondere la verità.
Alcune delle armi usate in via Fani e quella adoperata per uccidere Moro appartenevano alla ‘ndrangheta, in particolare due fucili mitragliatori Skorpion che furono in seguito dati in custodia dal boss reggino Orazio De Stefano a Nino Fiume, divenuto nel 2002 collaboratore di giustizia.
I progetti per liberare Moro Simona Zecchi
Un altro aspetto molto controverso dell’affaire Moro concerne i contatti reconditi tra politici e criminali per liberare lo statista pugliese, avviati parallelamente alle trattative portate avanti dai familiari del prigioniero, dal Vaticano, dall’Organizzazione per la Liberazione della Palestina e dal Partito Socialista Italiano (supportato da esponenti di Autonomia Operaia).
Un primo contatto con personaggi della ‘ndrangheta – «disponibili a salvare il presidente della Dc in cambio di vari “lasciapassare”» – fu intrapreso dal democristiano Benito Cazora. I boss calabresi, infatti, avevano identificato una delle prigioni di Moro ed erano pronti a eseguire un blitz per liberarlo. Simona Zecchi
Tra le persone avvicinate da Cazora ci fu anche Fonti che, il 20 marzo 1978, s’incontrò a Roma col segretario della Dc Benigno Zaccagnini, il quale gli avanzò la seguente richiesta: «Ci dia una mano e la Dc, di cui mi faccio garante, saprà sdebitarsi». L’iniziativa della ‘ndrangheta, tuttavia, non andò in porto, perché alcuni politici si opposero di continuare la trattativa.
Fonti, comunque, telefonò anonimamente alla Questura di Roma, segnalando l’appartamento di via Gradoli, dove Moretti dormiva con Barbara Balzerani, anche se poi trascorse più di una settimana prima che – fuggiti i brigatisti – il covo fosse perquisito dalla polizia, in seguito a uno strano allagamento.
Anche il boss della camorra Raffaele Cutolo – secondo il pentito Pasquale D’Amico – pensò di reclutare dei killer professionisti per «affrontare i brigatisti in un conflitto a fuoco», ma il suo progetto fu respinto da Antonio Gava e Nicola Lettieri, dirigenti democristiani nemici di Moro.
Stessa sorte subì l’idea del boss di Cosa Nostra Stefano Bontade che – secondo il pentito Francesco Marino Mannoia – era disposto a prendere contatti con Renato Curcio nel carcere di Torino per convincere i brigatisti a liberare Moro. Il rifiuto opposto a Bontade da Pippo Calò e Totò Riina – che ritenevano Moro «amico dei comunisti» – fece però fallire l’iniziativa.
Le varie prigioni di Moro
Un’altra verità inquietante, emersa nelle indagini più recenti, è il fatto ormai acclarato che Moro fu custodito in più prigioni, probabilmente tre: i brigatisti rossi, quindi, mentirono quando indicarono in via Montalcini l’unico carcere dove sarebbe stato segregato durante i 55 giorni del sequestro.
Subito dopo il rapimento, il presidente democristiano fu trasportato con un furgone nel quartiere romano della Balduina e rinchiuso in un appartamento di via Massimi, che si rivelò in seguito come uno dei covi romani delle Br, all’interno di uno stabile di proprietà dell’Istituto per le Opere di Religione.
In un secondo momento, Moro fu trasferito a Vescovio, in provincia di Rieti, in un alloggio usato da vari gruppi terroristici (Brigata XXVIII marzo, Prima Linea, Unità Combattenti Comuniste), scoperto nel 1979. Le perizie eseguite sul corpo e sui vestiti di Moro, infatti, hanno evidenziato la presenza di sabbia, di bitume e di un tipo di roccia calcarea che si trova solo nel Reatino, «dove si è sedimentata sin dal mesozoico».
Il giudice Giovanni Canzio, in un’intervista rilasciata nel 1979 al quotidiano l’Unità, dichiarò di essere stato sul punto di scoprire il covo di Vescovio, nelle settimane successive al rapimento di Moro, ma di aver dovuto interrompere le ricerche dopo il finto volantino delle Br del 18 aprile che «indicava nel Lago della Duchessa il corpo di Aldo Moro».
Il falso comunicato fu in realtà stilato dal falsario Tony Chichiarelli, legato alla Banda della Magliana, che lo dattiloscrisse su input dei servizi segreti nostrani per depistare le indagini di Canzio e permettere ai brigatisti rossi di spostare il prigioniero. Moro, infatti, fu trasferito nella zona della Magliana e rinchiuso nel covo di via Montalcini, dove rimase fino alla morte.
Il connubio terrorismo-malavita
I rapporti tra terroristi rossi e criminalità organizzata non si limitarono soltanto al Caso Moro. Le Br e vari gruppi dell’eversione di sinistra – come peraltro i terroristi di destra – collaborarono con la malavita in svariate occasioni, come testimoniano i risultati delle indagini condotte su tanti sequestri degli “anni di piombo”: Gianni Bulgari (1975), Giuseppe De Gennaro (1975), Carlo Saronio (1975), Guido De Martino (1977), Pietro Costa (1977), Massimiliano Grazioli (1978), Ciro Cirillo (1981).
Il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e il giudice Vittorio Occorsio indagarono per capire se i numerosi sequestri di persona dei primi anni Settanta non fossero riconducibili a «una struttura unica in grado di dirigere organicamente la regia», senza peraltro concludere le proprie inchieste (il Nucleo speciale antiterrorismo diretto da Dalla Chiesa fu sciolto nel 1975, mentre l’anno dopo Occorsio fu ucciso dal neofascista Pierluigi Concutelli).
L’ipotesi dell’esistenza di «una struttura riservata a guida dei sequestri e di altre attività criminali» è stata riproposta, nel corso dei lavori della II Commissione Moro, dall’ex colonnello dei carabinieri Michele Riccio che ha riferito le rivelazioni di un informatore, il mafioso siciliano Luigi Ilardo, il quale gli parlò di stretti contatti tra Cosa Nostra e la colonna torinese delle Br.
Un altro enigma rimasto irrisolto riguarda le ragioni dei tre viaggi compiuti da Moretti in Sicilia e in Calabria a metà degli anni Settanta, all’insaputa del resto delle Br. Nel dicembre 1975, il brigatista rosso soggiornò a Catania, mentre alcuni mesi dopo si spostò a Reggio Calabria, dove incontrò il mafioso Aurelio Aquino, in casa del quale furono rinvenute «banconote appartenenti al riscatto per la liberazione dell’armatore genovese Costa, versato proprio alle Br di Moretti». Nel 1978, infine, egli trascorse l’estate nei pressi di Tropea, in compagnia della figlia e del terrorista rosso Corrado Alunni.
Altri personaggi enigmatici
Il saggio di Simona Zecchi contiene importanti riferimenti ad alcuni personaggi che, all’epoca del sequestro Moro, si collocavano nell’area di Autonomia Operaia contigua alle Br. In particolare, si parla di Franco Piperno, Fiora Pirri Ardizzone e Nino Russo, che insegnavano o lavoravano ad Arcavacata di Rende presso l’Università della Calabria e che furono coinvolti in varie vicende giudiziarie poiché sospettati di fiancheggiare i terroristi rossi.
Un’altra figura controversa che compare nel libro è quella di Alessio Casimirri, la “primula rossa” che partecipò al sequestro di Moro per poi rifugiarsi in Nicaragua, dove è tuttora latitante. Secondo il magistrato Antonio Marini, Casimirri fu infiltrato nelle Br dal Sismi che «avrebbe saputo tutto quello che voleva sapere su via Fani e sulla prigione di Moro e poi lo avrebbe fatto fuggire all’estero».
Simona Zecchi mette in risalto anche il ruolo che nella morte di Moro fu svolto da Steve Pieczenik, funzionario del Dipartimento di Stato degli Usa e psichiatra specializzato nella lotta al terrorismo, il quale entrò a far parte del Comitato degli esperti costituito presso il Viminale, subito dopo l’agguato di via Fani, dal ministro degli Interni Francesco Cossiga.
Pieczenik – che nel 2008 ha ammesso le proprie colpe morali nel libro Abbiamo ucciso Moro (Cooper), scritto col giornalista francese Emmanuel Amara – nel 2013 ha rilasciato un’intervista radiofonica a Gianni Minoli, nella quale ha ribadito di aver impedito la liberazione di Moro: «No, non ero favorevole all’iniziativa del Vaticano volta a trarre fuori dal sequestro Aldo Moro attraverso il riscatto; fui io a bocciarla. In quel momento stavamo chiudendo tutti i possibili canali attraverso cui Moro avrebbe potuto essere salvato».
Alla luce delle novità emerse negli anni più recenti, dunque, il Caso Moro va interpretato in maniera diversa: l’omicidio dello statista democristiano, infatti, non fu soltanto un folle attacco eversivo alla democrazia in Italia, ma il frutto più marcio della “strategia della tensione”, il cui significato recondito va ricercato «nelle logiche politico-criminali che hanno trasformato questo paese lentamente ma inesorabilmente negli ultimi quarant’anni».
Giuseppe Licandro Simona Zecchi
(www.excursus.org, anno X, n. 89, agosto-settembre 2018) Simona Zecchi








