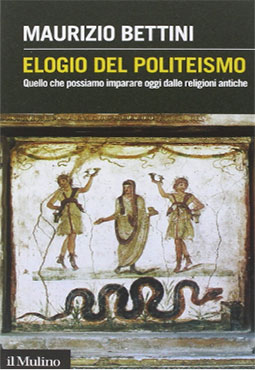 di SALVATORE GASPA – Non vi è forse termine che più di ogni altro richiami alla mente l’essenza delle civiltà antiche. La parola-concetto di “politeismo” rappresenta uno dei campi di indagine più investigati negli studi sulla religione e il culto delle società del mondo antico e, ad un tempo, uno dei tratti di maggiore fascino e complessità del pensiero religioso. Nell’ultimo libro di Maurizio Bettini, dal titolo solo in apparenza provocatorio, Elogio del politeismo. Quello che possiamo imparare oggi dalle religioni antiche (il Mulino, pp. 156, € 12,00), il lettore, con sorpresa crescente, scoprirà quale forza e ispirazione per il vivere contemporaneo possa avere riprendere un pensiero e una pratica politeistica.
di SALVATORE GASPA – Non vi è forse termine che più di ogni altro richiami alla mente l’essenza delle civiltà antiche. La parola-concetto di “politeismo” rappresenta uno dei campi di indagine più investigati negli studi sulla religione e il culto delle società del mondo antico e, ad un tempo, uno dei tratti di maggiore fascino e complessità del pensiero religioso. Nell’ultimo libro di Maurizio Bettini, dal titolo solo in apparenza provocatorio, Elogio del politeismo. Quello che possiamo imparare oggi dalle religioni antiche (il Mulino, pp. 156, € 12,00), il lettore, con sorpresa crescente, scoprirà quale forza e ispirazione per il vivere contemporaneo possa avere riprendere un pensiero e una pratica politeistica.
L’autore inizia il suo itinerario attraverso l’esilio degli dèi antichi chiedendosi come mai, a differenza del teatro e della filosofia, la religione antica non sia sentita attuale: tra le ragioni di questo esilio la censura operata dal cristianesimo ha certamente giocato un ruolo fondamentale nel confinare la complessità del politeismo al di fuori del vivere e del pensare quotidiano. Come hanno giocato un ruolo non indifferente la visione evoluzionistica del fenomeno religioso e, ultimo ma non per importanza, gli stessi storici della religione: questi fattori hanno reso le religioni antiche nella percezione comune come qualcosa di superato e oggetto di discussione elitaria di pochi accademici.
Con uno stile asciutto e senza perdersi nell’annoso dibattito tra monoteismi e politeismi, l’autore, con acutezza, pone all’attenzione del lettore i “quadri mentali” che soggiacciono a quello che potremmo definire il “pensiero politeista” e lo fa offrendo a chi legge diverse situazioni del vivere quotidiano, in cui il problema del rapporto con le “divinità degli altri” è diversamente risolto a seconda che lo si affronti con un “quadro mentale” politeistico o con quello, più vicino al sentire comune, ispirato al monoteismo.
Il primo capitolo tocca il cuore del problema, a partire dall’analisi di due atteggiamenti religiosi che sono frequentemente oggetto del dibattito pubblico italiano: uno è la scelta di non allestire il presepe per non turbare chi segue tradizioni diverse, l’altro quello di non accettare o di voler eliminare simboli e luoghi religiosi di chi professa un altro culto. Sebbene contrapposte, entrambe le posizioni, per Bettini, originano dallo stesso “quadro mentale” per cui non vi è che “un solo ed unico Dio”. Questo è certamente il portato della tradizione monoteistica, che concepisce la natura di Dio come esclusiva: a tal punto questo concetto è stato interiorizzato nel corso dei secoli, e fatto proprio da chi crede come da chi non crede, che l’idea di Dio è associata a quella di unicità e di esclusività; di conseguenza, pensare “dio” porta necessariamente ad escludere l’esistenza di altre divinità. Venerare due o più divinità nello stesso luogo, da parte dello stesso credente, è cosa inimmaginabile oggi: lo dimostra la totale assenza di questo tema nel dibattito pubblico. Eppure, il “quadro mentale” che ispira la pratica politeistica avrebbe molto da insegnare all’uomo moderno e ai suoi approcci esclusivisti in fatto di dio e rispetto delle fedi altrui.
Riprendendo gli esempi dell’autore, ci si chiede perché non si possa celebrare tanto il Natale quanto il Ramadan, e onorare dio recandosi in moschea dopo essere entrati in chiesa? Per fare ciò, però, occorrerebbe essere capaci non solo di pensare insieme diverse entità divine, ma anche e soprattutto di metterle su di un piano di reciproche corrispondenze: è questa l’unica via per integrarle in uno stesso sistema religioso, in cui il culto dell’una non escluda quello dell’altra, ma viva proprio di tale pluralità. Di cui Bettini offre al lettore diversi esempi che dimostrano il fil rouge che lega tradizioni religiose attuali con quelle del cosiddetto “paganesimo” delle società antiche.
I capitoli dal II al IV si focalizzano sull’analisi dell’utilizzo di statuette e figurine divine sia nel presepe del mondo moderno, sia nel larario degli antichi Romani. Il presepe si rivela allo sguardo attento dell’autore la riaffermazione plastica di una memoria culturale che racconta l’unicità e l’esclusività di Dio. La festa dei Sigillaria nell’antica Roma costituisce un parallelo interessante alla pratica del presepe moderno: erano sette giorni in cui i cittadini dell’Urbe allestivano il larario, presentando statuine di gesso a Saturno, in una dimensione di carattere affettivo-familiare che comportava lo scambio di doni tra amici e soprattutto in favore dei bambini. Evidentemente, onorare Saturno non offendeva coloro che veneravano altre divinità, quali i Lares compitales o la Magna Mater o Iside. Infatti il larario poteva raccogliere divinità appartenenti a diverse tradizioni culturali, oltre che figurine di imperatori divinizzati, poeti e condottieri del passato: tutti presenti, senza che vi fossero rapporti gerarchici tra un dio sentito superiore agli altri o esclusivo.
Bettini affronta il tema dell’esclusività del dio del monoteismo nel V capitolo, riconoscendo come uno dei tratti peculiari del monoteismo ebraico, messi in luce nei lavori di Jan Assmann, in particolare Mosè l’egizio (Adelphi) e Non avrai altro Dio (il Mulino), sia l’esclusività di Dio: il dio ebraico e delle successive tradizioni monoteistiche (la cristiana e l’islamica) è un dio “geloso”. Dio vieta che si onorino altri dèi. Da qui la qualificazione delle divinità degli “altri” come “false” e la violenza di matrice religiosa come pratica frequentemente attestata in società monoteistiche. Nel mondo antico, tra società politeistiche in guerra, i conflitti e le violenze non erano perpetrati per affermare la verità dell’unico dio sulle false religioni dei nemici, come osserva l’autore. Le divinità degli “altri” venivano integrate nel proprio sistema religioso, non negate. Lo zelo alla conversione di chi professa fedi diverse è parte integrante di questo “schema mentale” monoteistico.
Ciò che si è perso, nel mondo moderno, è proprio il concetto di “traducibilità” delle diverse divinità: le divinità “altre” rispetto al Dio ebraico, cristiano e islamico non possono essere nemmeno pensate in un quadro di corrispondenza con esso. Invece, proprio questa “traducibilità”aveva permesso alle civiltà del mondo antico di far corrispondere le divinità degli altri alle proprie e, così facendo, di integrarle pienamente nel proprio sistema religioso. Nel “quadro mentale” politeistico, la traducibilità delle figure divine degli altri nelle proprie non tradiva, tuttavia, la natura del proprio dio né quello del suo culto: ogni divinità conservava specifici culti e rituali nelle città dove era venerata. Tale“traducibilità” era segno di un approccio culturale aperto e curioso, che si applicava non solo verso l’esterno, a spiegare le divinità degli altri attraverso le proprie, ma anche verso l’interno del proprio sistema religioso, per chiarire l’identità delle proprie divinità attraverso relazioni di identificazione con dèi dello stesso pantheon.
Un punto di particolare interesse è trattato nel IX capitolo, quando l’autore afferma che il conflitto a carattere religioso non trova spazio per manifestarsi in un contesto culturale politeistico: le ragioni risiedono nel fatto che la pluralità dei “nostri” dèi e la “traducibilità” di quelli degli altri nei “nostri” impediscono infatti tale conflittualità, prefigurando invece, nell’assimilazione, un’opportunità e una risorsa. In un orizzonte culturale monoteistico, invece, chi professa la fede nell’unico vero Dio, non ha bisogno di conoscere divinità altrui per eventualmente integrarle nel proprio sistema religioso.
Un altro elemento che caratterizza il sistema politeistico è il suo carattere aperto e infinitamente produttivo: nuove divinità potranno essere create, assieme a quelle “straniere” che eventualmente entreranno a far parte del “nostro”sistema, una volta interpretate e assimilate. Possibilità che non si dà nel mondo monoteistico: non è consentito dare cittadinanza agli dèi poiché la percezione che si ha del divino non è “civica”, come nel mondo antico, bensì improntata all’esclusività e alla verità del proprio dio.
Dalla lettura di questo breve ma pregevole saggio emerge l’enorme potenzialità che una ripresa della “traducibilità” e della curiosità a conoscere divinità “altre” avrebbe in quello che oggi chiamiamo “dialogo interreligioso”. Forse, proprio questo approccio politeistico ci permetterà di superare pienamente il concetto di tolleranza religiosa e le sue insidie, orientandoci verso i ben più inclusivi e saldi concetti di rispetto e cittadinanza di ogni forma del divino.
Salvatore Gaspa
(www.excursus.org, anno VIII, n. 74, luglio-agosto 2016)








