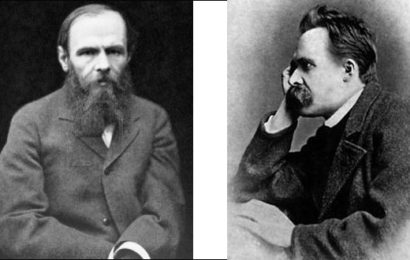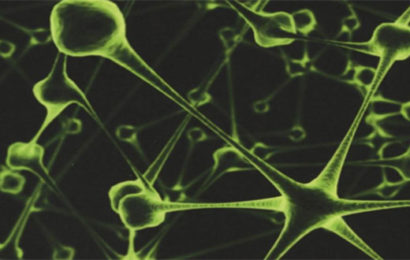di MARCO GATTO – «Il tempo delle scelte è andato», scrive in modo plastico e definitivo Michele Cariglino. E la fermezza di tale giudizio arriva agli occhi e alle orecchie del lettore dopo un attraversamento, tanto lucido quanto sofferto, di un esistente che è ridotto a brandelli, a incongruenze, a disintegrazioni.
di MARCO GATTO – «Il tempo delle scelte è andato», scrive in modo plastico e definitivo Michele Cariglino. E la fermezza di tale giudizio arriva agli occhi e alle orecchie del lettore dopo un attraversamento, tanto lucido quanto sofferto, di un esistente che è ridotto a brandelli, a incongruenze, a disintegrazioni.
Il poeta può allora limitarsi a scorgere sul proprio corpo – dal momento che la propria autorevolezza letteraria sembra essersi persa nel frastuono di un’epoca che ne rifiuta la presenza e la voce – i brandelli di una realtà che appare poco addomesticabile e che pure sembra conferire un significato alla propria vocazione apocalittica, distruttiva, nichilistica.
L’anatomia della disfatta, sia personale che storica, è condotta da Cariglino mediante una tecnica versificatoria che elegge la reductio a norma, la capacità di asciugare (o persino prosciugare) qualsivoglia tentazione decorativa a condotta anzitutto morale prima che letteraria. È dalla presa di coscienza di questa inestinguibile consunzione – forse riflesso di un Io poetico che, di fronte alla sconfitta, può e deve far esperienza, per rinascere, dell’abisso – che si diparte un allontanamento silente dal “mito” stesso della poesia, e da quella tradizione lirica che, particolarmente nel nostro Paese, ha avuto un peso non indifferente. Il dialogo con i padri – dichiarato a piena voce nel caso del Montale più maturo («Sciolgo un tango / e chiedo a Clizia la rituale indulgenza»), taciuto in altre occasioni (ma certamente vivo nel modo in cui Cariglino concepisce il suo dettato e dichiara la sua presenza: forse Ungaretti, o forse Sereni, restano interlocutori nascosti o involontari) – sembra spezzarsi non in virtù di un’insopportabilità cogente o di un ribellismo gratuito, ma grazie a un’attitudine al dubbio (espressione che, non a caso, padroneggia la parte centrale del libro) che fa dell’autore calabrese uno scettico dell’autocoscienza poetica.
Non siamo di fronte al solito tentativo, continuamente proposto dalle giovani generazioni in fuga dalla tradizione o desiderose di accaparrarsi un proprio territorio, di cogliere nella marginalità dell’Io un espediente per poter affermare la propria inequivocabile identità (supposta flebile, ma tanto vigorosa quanto tenacemente pervasiva e vitalistica). No.
In Cariglino l’accettazione del margine è benefica perché limita l’Io nella misura in cui la propria voce diventa tutt’uno con l’esistente, in una sorta di panismo al negativo o al contrario, di patteggiamento con i brandelli della realtà, che mai si piega a un’accettazione passiva o a un’interlocuzione bonaria. La poesia è volontà di conoscenza che va di pari passo con la disintegrazione di quei pregiudizi o di quei preconcetti che, se pervasivi, ne annullerebbero la sua vocazione veritativa e sapienziale. Del desiderio investigativo, e del suo legame implicito con un’esperienza di verità, è testimonianza il verso del giovane poeta. Ogni affermazione sembra possedere il carattere definitivo di un’occasione mancata.
Il verso si chiude in sé nel giro di poche parole. Di fronte alla magmaticità del reale, la parola poetica sembra farsi forza riducendo se stessa, puntando a un’essenzialità che è certamente forza, capacità di resistenza, potenza espressiva. E ciò non impedisce certo a Cariglino – qui a una seconda prova poetica che conferma la speranza nutrita nel suo esordio, Irene lisergica – di accedere a momenti di libertà: laddove può, il poeta canta; prima di spegnersi nella sentenza, la musica (che è anche motivo conduttore dell’intera raccolta) si insinua nelle pieghe del verso. Ma anche la musica, da eldorado vagheggiato, può diventare uno strumento della menzogna, uno strumento di disorientamento (cui il poeta, tuttavia, non smette di attribuire un’incondizionata fiducia): «Sono il luogo della mia solitudine, / lì, dove l’archetto tenta la corda / e fallisce misura, sostanza e menzogna». Era perciò inevitabile che una poesia tanto austera nel presentarsi come esito di un’amara riflessione sul presente si comunicasse al lettore alla stregua di una testimonianza.
La solitudine del poeta, parafrasando uno dei componimenti più sentiti della raccolta, è un privilegio tenuto in vita al costo di una falsa presenza sociale. Il poeta, per sopravvivere, ha bisogno di convertire la sua prigionia in un’occasione salvifica («Urge una cella sicura / dove, insieme, covare figli»), pur nella disillusa consapevolezza di mantenere in vita un discorso ormai disintegrato, ormai estinto, dunque da proteggere, appunto da covare. Perché nei dettagli di questa esistenza montaliana o sbarbariana (ciottoli, conchiglie, lo scabro panorama ramato dello Jonio, solcato da uno scirocco che punge) non si scorge più una luminosa salvezza o un varco miracoloso, ma una presenza immobile, un’ombra che non riesce a sfaldarsi e permane, anche se minima: «Un vibrato resiste / nella calura della stanza, / fuori l’ombra si accorcia, / risuona appena».
Non rimane che un segnale da lanciare nel vuoto. La poesia è un «Graffio / amorfo e malnutrito / sulla parete della caverna»: forse un giorno, quando non ci saremo più, qualcuno saprà scorgerlo di sorpresa, il graffio della poesia, e saprà accogliere la sua verità postuma, la sua lezione per chi, nonostante tutto, è venuto dopo.
Marco Gatto Michele Cariglino
Su gentile concessione della Pungitopo Editrice, abbiamo pubblicato in anteprima la Prefazione di Marco Gatto al volume Croniche (pp. 64, € 7,50) di Michele Cariglino, raccolta poetica in libreria in questi giorni.
(www.excursus.org, anno VI, n. 65, dicembre 2014) Michele Cariglino