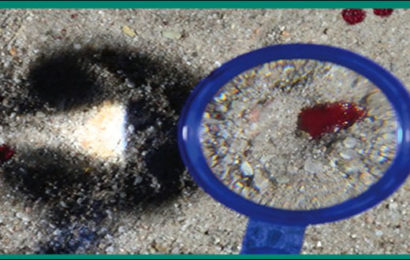di SIMONA OLIVIERI – «Budrio è un antico castello della città di Bologna, ha belle mura cinte da un fossato e due porte, una a settentrione e una a mezzogiorno. […] La chiesa è grande, ha un alto campanile e il convento accanto, con il chiostro e la torre dell’orologio».
di SIMONA OLIVIERI – «Budrio è un antico castello della città di Bologna, ha belle mura cinte da un fossato e due porte, una a settentrione e una a mezzogiorno. […] La chiesa è grande, ha un alto campanile e il convento accanto, con il chiostro e la torre dell’orologio».
È l’anno del Signore 1644, quando il frate Giovanni Battista Mezzetti, uno dei diciassette confratelli che abitano nel convento, ha un incontro con un bambino dagli occhi grandi e un po’ sporgenti, di nome Giacomo Modanesi.
Giacomo ha la camicia sudicia, i piedi nudi nonostante sia il mese di febbraio, e mendica subito fuori dalla soglia della Chiesa di San Lorenzo. Alla risposta negativa e ammonitrice del religioso, Giacomo gioca inconsapevolmente d’astuzia e controbatte promettendo che, in cambio di una moneta, reciterà l’intera messa e «anche la Salve Regina e il Veni Creator».
Frate Giovanni non tarda a capire che il bambino ha qualcosa di speciale. Infatti è breve il periodo di tempo che intercorre tra quel primo incontro e l’entrata di Giacomo nella scuola del paese, fondata e curata dall’ordine religioso, e seguita in quegli anni proprio da Padre Mezzetti. Giacomo non ha ancora compiuto cinque anni,è figlio di un garzaiolo che a stento riesce a portare a casa il pane, ed è orfano di madre; eppure, a scuola è sprecato, troppo intelligente, con una memoria fuori dall’ordinario anche per un adulto. Padre Giovanni, in ottemperanza ai precetti evangelici che ricordano di coltivare i talenti donati dal Signore, decide allora di dargli una possibilità unica: entrare nel convento ed essere formato per diventare poi, un giorno, un confratello nell’Ordine dei Servi di Maria, e chissà forse persino cardinale… persino papa.
È con questa consapevolezza che Giacomo studia, prega e si aggira per gli spazi aperti all’interno del convento, nelle ore libere dallo studio. Ci sono degli altri bambini, ma non lo coinvolgono spesso nei loro giochi, specialmente quando vedono Padre Giovanni prenderlo per un braccio e trascinarlo via dal chiostro. «Gli avete estorto l’impegno con la paura e la paura è una medicina amara, lo sapete. Il sapore dura a lungo sul palato, non si dimentica…». Padre Michele, e non soltanto lui, cerca di insinuare un sano dubbio nel cuore di Padre Giovanni – uomo dotato di grande determinazione e ambizione, sapiente e studioso tanto da essere considerato dai più un teologo anziché solo un frate – ma egli si sente investito di una missione: se il Signore ha messo sulla sua strada Giacomo, lui non può rifiutarsi di rispondere alla chiamata e deve accettare il mandato, qualunque ne sia il costo.
Il perché del romanzo Il bambino di Budrio di Angela Nanetti (Neri Pozza, pp. 300, € 17,50) si può intuire sin dalle prime pagine, oltre che dalla presentazione scritta in quarta di copertina: «Perché un’attitudine paterna si trasforma in divorante ambizione? E che cosa spinge verso la rovina un legittimo desiderio di gloria?».
Angela Nanetti, autrice capace e ammirata di libri per bambini – tra cui Mio nonno era un ciliegio (Einaudi Ragazzi), Gli occhi del mare (Einaudi Ragazzi) e Le memorie di Adalberto(Giunti) – affronta in questo romanzo tematiche non così lontane dalla sua esperienza di insegnante: il rapporto tra alunno e docente, i metodi di insegnamento, le dinamiche psicologiche e affettive che nascono in queste occasioni, i sensi di colpa, la paura, la devozione e le aspettative. Col dipanarsi del filo narrativo, il lettore è portato ad interrogarsi sull’effettiva legittimità delle punizioni inflitte, dei metodi coercitivi utilizzati e di un conseguente timore reverenziale che sfocia in vera e propria paura da parte dell’alunno nei confronti dell’insegnante.
Ad ispirare Angela Nanetti è una storia realmente accaduta, di cui – racconta lei stessa nelle interviste – ha avuto poco più di una suggestione: un’incisione su una lapide, posta un tempo sul muro d’entrata della Chiesa di San Lorenzo di Budrio, che ha risvegliato la sua curiosità e l’ha sollecitata tanto da spingerla a ricercare la storia di questo bambino prodigio, questo «dotto putto» le cui doti sono state fatte oggetto di spettacolo sin nella Roma di Papa Innocenzo X.
È dunque esistito Padre Giovanni Battista Mezzetti, come sono esistiti Giacomo Modanesi e i personaggi della Roma di metà Seicento che la scrittrice mette in scena: Papa Innocenzo X, donna Olimpia Maidalchini, cognata del papa e vera regista di quel papato, e naturalmente i due artisti che hanno progettato la Roma barocca, Gianlorenzo Bernini e Francesco Borromini, che si sfidano a suon di progetti grandiosi di fontane, sculture e chiese.
Chi non è esistito è la voce narrante della storia, il medico del paese, Alberto Carradori, che racconta dal suo punto di vista l’intera vicenda, aiutato dall’inserimento ad hoc di epistole e di dialoghi. «Mi serviva un personaggio che fosse coinvolto nella vicenda abbastanza da sapere tutto ciò che di necessario c’era da sapere», racconta Angela Nanetti nelle interviste. Il dottor Carradori, infatti, è medico del paese e del convento, e dunque, nel momento del bisogno, anche medico personale di Giacomo, che necessita più volte di cure nel corso del romanzo. Tra salassi – al tempo metodo principe per ristabilire ogni male – e medicinali amari – forgiatori di un animo forte – Alberto conquista la fiducia di padre Mezzetti, al punto che non solo quest’ultimo chiederà al medico di seguire lui e Giacomo nel viaggio a Roma, ma si confiderà totalmente con lui, dandogli accesso ai punti più reconditi dell’animo.
«Non ci sono più, le galere se ne sono andate! Forse sono già arrivate alle due grandi isole e sono ripartite… C’è dell’altro mare dopo… Davanti è la Reale tutta d’oro, che brilla, il vento soffia e gonfia le vele… come quella nave dipinta che andava al Nuovo Mondo… Premono sui remi e corre, corre…».
Sono frequenti nel testo artifici di questo tipo: monologhi intrisi di reticenze, che ricordano i flussi di coscienza nell’Ulisse di Joyce, che procedono per associazioni di idee, e che in tal modo rendono la verità che il romanzo richiede. In un bambino i flussi di coscienza sono ancora più legittimi, e i discorsi a “cuore aperto” che Giacomo fa alla vista di una nave, sia essa dipinta, sottoforma di giocattolo, o reale, sono magistralmente disseminati nella narrazione, inseriti ogniqualvolta si allontana dal lettore l’idea che è di un bambino che si parla, e non di un adulto che ha scelto una vita di studi e devozione a Dio.
Lo scritto di Angela Nanetti è un’autentica opera prima (poiché è il suo primo romanzo per adulti), ben costruita nelle ambientazioni e nel filo narrativo. L’attenzione va, a nostro parere, alle descrizioni dei luoghi, accurate e frutto di una ricerca sul campo, ma anche e soprattutto allo sforzo di immedesimazione in personaggi, valori e orientamenti che non appartengono all’autrice: ogni punto di vista, ogni scambio di battute è talmente ben costruito da sembrare il verbale di un dialogo, e non una semplice ricostruzione sulla base della fantasia. In sequenze colloquiali, a volte molto brevi, l’autrice rende sempre i suoi personaggi portavoce di tematiche delicate e importanti, arrivando spesso a conclusioni a cui il lettore può soltanto annuire con il capo, perché sono verità assolute.
Si percepisce, allo stesso tempo, ed in ciò si ritrova l’autrice per bambini, l’amore per l’età infantile nella sua libertà di espressione e nella sua innocenza. Traspare la spinta pedagogica della scrittrice, che s’indigna nel momento in cui l’infanzia nella sua dimensione di libertà di gioco e sogno viene negata. Indipendentemente dall’etica che sta dietro al gesto di prendere un bambino dalla strada per indirizzarlo verso un futuro già scritto, senz’altro quella dei bambini come Giacomo può definirsi un’infanzia negata.
Insomma, il «dotto putto», grazie agli insegnamenti del suo maestro, saprà anche disquisire in latino, tradurre il greco e saper leggere qualcosa in aramaico, ma ancora ha domande a cui deve trovare una risposta: «Quanta forza ci vuole per i remi?».
Simona Olivieri Angela Nanetti
(www.excursus.org, anno VII, n. 67, febbraio 2015)