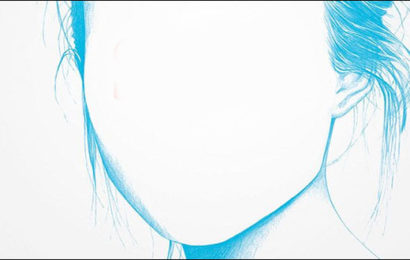di FEDERICA CHIMENTON – Il tema della maternità è sempre stato presente nelle storie sin dall’origine dell’uomo, e ancora prima dell’invenzione della scrittura veniva raccontato attraverso le immagini. Successivamente, nel corso del tempo, la letteratura ci ha lasciato in eredità madri diventate celebri per un motivo o per l’altro, per esempio la Signora Bennet in Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen o la Signora March in Piccole donne di Louisa May Alcott. Donatella di Pietrantonio
di FEDERICA CHIMENTON – Il tema della maternità è sempre stato presente nelle storie sin dall’origine dell’uomo, e ancora prima dell’invenzione della scrittura veniva raccontato attraverso le immagini. Successivamente, nel corso del tempo, la letteratura ci ha lasciato in eredità madri diventate celebri per un motivo o per l’altro, per esempio la Signora Bennet in Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen o la Signora March in Piccole donne di Louisa May Alcott. Donatella di Pietrantonio
È solo recentemente, tuttavia, che questo tema è stato oggetto di uno sdoganamento totale in tutte le sue sfaccettature, in particolare quelle negative o semplicemente ritenute finora “scomode”.
Il romanzo L’Arminuta di Donatella di Pietrantonio, edito da Einaudi e vincitore del Premio Campiello 2017 (Einaudi, pp. 176, € 17,50), affronta tra gli altri il tema di una maternità complessa, non voluta, a tratti negativa e difficile da accettare. È la stessa autrice ad affermarlo: in un’intervista ha infatti detto che la maternità «è la mia urgenza narrativa. […] Mi interessa andare a guardarla nelle sue pieghe nascoste, nelle parti in ombra, nelle anomalie». Di Pietrantonio, classe 1963, ha una doppia vita: di giorno dentista pediatrica e di notte, o meglio la mattina, in una fascia che va dalle cinque alle sette, scrive ininterrottamente. L’Arminuta è il suo terzo romanzo, preceduto da Mia madre è un fiume (edito da Elliot Edizioni) e Bella mia (da poco ripubblicato da Einaudi), con cui ha gareggiato al Premio Strega nel 2014.
L’Arminuta è la storia della restituzione di una figlia tredicenne – l’Arminuta appunto, che in dialetto abruzzese significa la Ritornata – alla sua famiglia biologica, che l’aveva affidata a dei parenti con maggiori possibilità economiche per cercare di assicurarle una vita migliore.
Siamo nel 1975 in Abruzzo, una terra fatta di silenzi e di lavoratori, talmente silenziosa che l’ambientazione scelta dall’autrice si evince da pochi dettagli: alcune pratiche descritte, il dialetto e un gioiello citato, la presentosa (una collana tradizionale femminile a forma tonda che presenta una dentellatura intorno al medaglione). Sappiamo che l’Abruzzo fa da sfondo alla storia perché è proprio lì che negli anni passati del Novecento c’era l’usanza, su cui l’autrice ha voluto indagare, di “dare” i figli a parenti lontani o a conoscenti, con l’intento di allontanarli dalla povertà e dagli stenti. L’artificio letterario è il ritorno stesso della protagonista che non ha nome e verrà sempre citata come l’Arminuta, perché il suo nome è la sua condizione. La ragazzina si trova dunque a tredici anni senza punti di riferimento che le permettano di decifrare la sua identità e la sua provenienza, dal momento che è stata abbandonata sia dalla sua madre biologica – di cui non conosciamo nemmeno questa volta il nome – sia dalla madre adottiva Adalgisa, una figura che a poco a poco diventa impalpabile, sfuggente, e che l’Arminuta non riesce più a rintracciare per poter avere spiegazioni circa le motivazioni dietro la sua restituzione.
«A tredici anni non conoscevo più l’altra mia madre. Salivo a fatica le scale di casa con un valigia scomoda e una borsa piena di scarpe confuse. Sul pianerottolo mi ha accolto l’odore di fritto recente e un’attesa. La porta non voleva aprirsi, qualcuno dall’interno la scuoteva senza parole e armeggiava con la serratura[…] Era mia sorella, ma non l’avevo mai vista. Ha scostato l’anta per farmi entrare, tenendomi addosso gli occhi pungenti. Ci somigliavamo allora, più che da adulte» (p. 3).
L’affollata famiglia d’origine non accoglie di buon grado la figlia che viveva nella città a 50 km di distanza dal mare: è una bocca in più da sfamare e una persona a cui trovare un posto dove dormire, troppo elegante e con una proprietà di linguaggio assai distante dal dialetto che loro parlano a tavola. L’unica persona a superare la riservatezza e il dolore silenzioso dell’Arminuta è la sorella Adriana, con cui nascerà un rapporto d’amore genuino e puro, un personaggio che è letteralmente «scoppiato tra le mani» a Donatella di Pietrantonio, a cui i lettori chiedono ferocemente di scrivere un romanzo a lei dedicato. Un personaggio piccolo quanto la sua età ma forte, coraggioso, senza peli sulla lingua e che sarà l’unica a dire la verità all’Arminuta sul suo ritorno:
«Io forse parlo un po’ troppo, certe volte» ha ammesso, ansimando per la salita.
«Non hai colpa se dici la verità. È la verità a essere sbagliata» (p. 139).
Gli altri fratelli, Sergio e Vincenzo, si abituano a lei poco a poco, ma Vincenzo in particolare non riesce a vederla come una sorella, tanto da intraprendere con lei quasi un’infantile relazione incestuosa, prima che un evento tragico lo allontani da casa. «Non eravamo abituati a essere fratelli e non ci credevamo fino in fondo. Forse non era per lo stesso sangue che lo tenevo fermo, una difesa l’avrei tentata con chiunque altro. Ansimavamo, sull’orlo dell’irreparabile» (p. 75).
È interessante notare come nessuna delle madri che popola il romanzo abbia un istinto materno vero proprio, ma ognuna di loro sia spinta o voglia essere spinta a essere madre per un motivo o per l’altro. Per la madre biologica i figli sono il semplice frutto della carnalità e dei doveri coniugali, mentre Adalgisa vuole disperatamente essere madre anche se non può, ecco perché, secondo la madre biologica, si è fatta avanti per adottare in via ufficiosa la figlia. L’Arminuta si angoscia e nutre il suo dolore con l’assenza di affetto che la fa sentire diversa dagli altri, trascinata da una famiglia all’altra senza spiegazioni ovvie e all’apparenza detestata da tutti alla stregua di un pacco sgradito. È proprio dell’affetto di una madre che ha bisogno e che fatica ora a trovare: «Sono scappata via e sono rimasta fuori, presto è sceso il buio e mi ha gelato. Dall’angolo più nascosto del piazzale vedevo le finestre illuminarsi e, dietro, l’andirivieni delle sagome femminili affaccendate. Erano ai miei occhi le mamme normali, quelle che avevano partorito i figli e li avevano tenuti con sé. Alle cinque del pomeriggio erano già intente ai preparativi per la cena, cotture lunghe, elaborate, così richiedeva la stagione. Nel tempo ho perso anche quell’idea confusa di normalità e oggi davvero ignoro che luogo sia una madre. Mi manca come può mancare la salute, un riparo, una certezza. È un vuoto persistente, che conosco ma non supero. Gira la testa a guardarci dentro. Un paesaggio desolato che di notte toglie il sonno e fabbrica incubi nel poco che lascia. La sola madre che non ho mai perduto è quella delle mie paure» (p. 100).
La scrittura di Donatella di Pietrantonio è cruda, senza orpelli, tanto sincera e cristallina da ferire, ma l’autrice sa dosarla perfettamente per descrivere il rapporto anomalo tra madri e figlia, la pressoché totale assenza dei padri – noti al lettore come il padre biologico e il Carabiniere come identificativo per quello adottivo – e il desiderio negato di affetto e attenzione che tutti i figli, in un modo o nell’altro, sembrano agognare disperatamente, incarnato alla perfezione ancora una volta dall’Arminuta: «Ho chiuso gli occhi dalla stanchezza, avrei voluto che tacesse e restasse ferma, almeno per un po’, soltanto qualche attimo di riposo per me, appoggiata a un corpo umano, perduta nel suo profumo, in una breve dimenticanza» (p. 142). La ragazzina cerca pertanto l’affetto in altre figure femminili che popolano la sua vita: la sua insegnante che vuole farle proseguire gli studi al liceo sebbene la famiglia sia contraria, le madri delle amiche della città.
Donatella di Pietrantonio, dunque, con il suo metodo di “non-scrittura” – come lo definisce lei – ci trasporta in un mondo tanto reale quanto doloroso, catapultandoci nella vita semplice e dignitosa dei protagonisti e facendoci riflettere sul legame tra madri e figli, sulla natura femminile e sulla messa in dubbio della propria identità e della coscienza di sé. L’Arminuta è un romanzo che necessiterebbe di due letture: una prima repentina, senza interruzioni, e una seconda più lenta, riflessiva e meditata, per farci condurre in un mondo lontano e vicino allo stesso tempo.
Federica Chimenton
(www.excursus.org, anno XI, n. 91, marzo-aprile 2019)