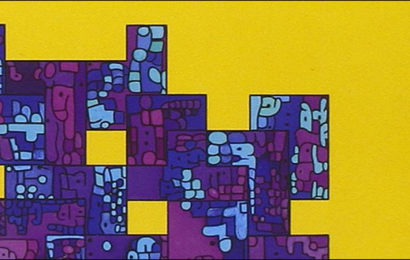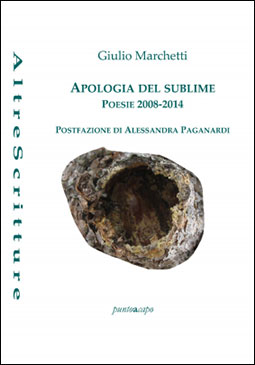 di ALESSIA PERETTA – Come può suonare la parola “sublime” all’orecchio del lettore odierno? Come, nell’ambito della contemporanea cultura di massa e massmediologica, magmatico calderone del tutto e del contrario di tutto all’interno del quale risulta spesso difficile distinguere, nella confusione delle idee e dei valori, «l’onore e l’indecenza» [1]?
di ALESSIA PERETTA – Come può suonare la parola “sublime” all’orecchio del lettore odierno? Come, nell’ambito della contemporanea cultura di massa e massmediologica, magmatico calderone del tutto e del contrario di tutto all’interno del quale risulta spesso difficile distinguere, nella confusione delle idee e dei valori, «l’onore e l’indecenza» [1]?
Forse, risponderanno gli spiriti più diffidenti, se non altisonante quantomeno anacronistica. Difficile credere a una categoria che, fatta eccezione per gli addetti ai lavori della speculazione filosofica, rischia di essere percepita come astratta, sfuggente e ormai lontana dal comune sentire.
Eppure così, provocatoriamente, Giulio Marchetti suggella il bilancio di un lavoro poetico maturato in sei anni e che leggiamo oggi nella silloge Apologia del sublime. Poesie 2008-2014 (Postfazione di Alessandra Paganardi, puntoacapo, pp. 144, € 14,00). Scelta coraggiosa di un’anima, si potrebbe dire, ancora umanista (seppure nell’unico modo possibile nell’età della crisi e della frantumazione del soggetto: in maniera intermittente, segnata da sconforti e battute d’arresto) che, recuperando la centralità della dimensione umana, ne rivendica la sofferta dignità nella sua incessante e inesausta ricerca di senso.
Primo e quasi necessario punto di forza di questa sua peculiare Apologia consiste senz’altro nella coerenza e nella compattezza della riflessione, garantita in primo luogo dalla ferrea tenuta di testi e motivi: la poesia di Giulio Marchetti nasce infatti, con Il sogno della vita (2008), come poesia d’amore e come tale si sviluppa fino all’inedito Disastri (2014). L’esperienza personale di un amore intenso e infelice si configura quindi come tema fondamentale e fondante delle raccolte, in quanto da racconto del proprio vissuto, incentrato su un rapporto io-tu rivisitato dall’a-posteriori dell’assenza, della distanza e dell’abbandono, il dettato poetico si allarga ben presto a riflessione sul senso del nostro esserci, rivelando in tal modo la più vera e profonda vocazione della silloge.
Al nocciolo duro di quell’amore che il giovane Giulio Marchetti vive e sconta in prima persona, il pensiero torna in continuazione e senza sosta s’interroga, mettendosi a nudo. Emerge così, dai primi componimenti, il ritratto di un io che ha faticato a emergere, pavido addirittura, che dopo aver ceduto alle facili quanto logoranti lusinghe della consuetudine scopre che l’amore era rischio, era mettersi in gioco.
«Mi ostino ormai in un vortice di spasimi uguali
che estrapola, quasi al limite dello strazio,
la mimica dell’urlo,
contrazioni vistose di mani e intelletto,
o ritorni sfiniti di consuetudine
a lato, stesi su tralicci marginali
da cui invocano il pericolo
come una promessa […]»
(Insisto, vv. 1-8).
L’innamorato ferito ha perso quanto, fino a quel momento, aveva illuminato la sua vita di senso, e ora la perdita di quello stesso senso lascia un vuoto che spasima per essere colmato. Ecco quindi irrompere, in prima istanza, una peculiare rivisitazione del mito della donna-angelo, a cui non solo si delega il compito di fornire dignità e identità all’amante, ma si attribuisce quella chiaroveggenza nell’opacità dell’esistenza che l’io considera per sé ancora irraggiungibile.
«Tu che segui le nuvole per trovare il cielo
esci da ogni raggio di stupore per farne coscienza
come il falco sa di avere le ali
prima degli occhi e le piume dorate già prima dell’alba
e ancora un istante di volo da aspettare
come se fosse tutto il tempo»
(Il volo, vv. 1-6).
La riflessione sul proprio vissuto non si appaga però di se stessa; al contrario, quella profonda nostalgia di senso diviene presto catalizzatrice di una più profonda e matura ricerca. Questa infatti si arricchisce di spunti sullo scorrere del tempo, sull’impossibilità di controllo sul proprio destino, sulla solitudine dell’uomo fra gli uomini (quell’essere crocifissi alla propria impossibilità di essere gli altri di cui parlava Pessoa) e su quel sentimento di compassione e solidarietà che nonostante tutto li tiene legati:
«Eppure hai solo corpi distanti da seguire.
Deboli e lontani per sperare di aiutarli.
Troppo vicini per non amarli»
(La finestra, vv. 7-9).
Ne emerge il quadro di un’umanità fragile e sola, costretta nella prigionia dello spazio e del tempo, che la condanna alla natura di creatura caduca e transeunte: «Nella perdita continua scopriremo / la nuova centralità dell’essere». Condizione che, nonostante tutto, Giulio Marchetti non manca di rovesciare in punto di forza e speranza per il futuro. Il soggetto si muove infatti, e incessantemente, lungo una direttrice verticale, che dall’abisso del dolore e delle ombre si tende in un inesausto anelito al cielo, cercando di carpire un poco del suo azzurro e della sua eternità. Emblematico in questo senso il profilo che del poeta viene tracciato in Troppo vicino, di cui il lettore non potrà non apprezzare l’elegante tocco di surrealismo magrittiano: «Io credo mi giovi questo stare di lato / con le scarpe dure di fango / e capelli pieni di cielo».
Ma i testi sono pieni di accostamenti di unità lessicali opposte e contrarie come questo,di imprevisti rovesciamenti di prospettiva e cortocircuiti semantici. Se il ruolo centrale ricoperto dalla vicenda del soggetto favorisce il permanere di una fedeltà al lirico e a certi suoi modi distintivi, come l’intenso ed elegante metaforismo, l’ampio ricorso all’analogia di gusto ermetico e certi tratti onirici, l’allargarsi della meditazione al rapporto tra l’uomo e il proprio destino apre al cospicuo ricorso ad antitesi e ossimori: figure per antonomasia dell’inquietudine esistenziale e tra le più distintive della poesia tragica.
«I lati più belli di me
non sono miei. Le cose più belle
della mia vita non sono cose.
Nulla appartiene a me,
io appartengo al nulla»
(No, vv. 1-5).
Nonostante ciò, non vi è spazio nella poesia di Giulio Marchetti per l’oscurità semantica o per vuoti di senso difficilmente colmabili. Al contrario, il rigore dell’indagine richiede compostezza e limpidezza di ragionamento, che il poeta persegue costruendosi uno spazio metrico-retorico-sintattico esatto e calibrato. Anche l’esperienza quotidiana viene sublimata di ogni traccia di realismo prendendo volentieri la direzione della pura riflessione astratta. Emblematici di tale concezione della poesia quale operazione precipuamente intellettiva sono verbi come cercare, indagare, scandagliare, enumerare, esplorare, conoscere, e così via, che rendono perfettamente il senso del fervore di una ricerca pervicacemente esercitata.
Ecco dunque farsi chiara la forza e il valore di Giulio Marchetti, poeta ancora così giovane: aver saputo trasformare questa ricerca di senso nata come fuga dal dolore di un amore tramontato, in profonda e radicata necessità di essere umano. E cosa, se non questo, potremmo intendere noi, oggi, come sublime?
Alessia Peretta
NOTA BIBLIOGRAFICA
[1] – «Ma dopo che le stalle si svuotarono / l’onore e l’indecenza stretti in un solo patto / fondarono l’ossimoro permanente», vv. 18-20, EUGENIO MONTALE, Lettera a Malvolio, inTutte le poesie, a cura di GIORGIO ZAMPA, Milano, Mondadori, 1984.
(www.excursus.org, anno VII, n. 68, marzo 2015)