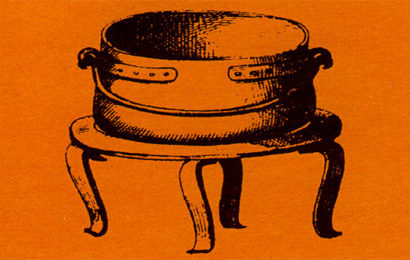di GAE SICARI RUFFO – Al Santuario con Pavese. Storia di un’amicizia (Edizioni Dehoniane, pp. 126, € 11,50) è l’intensa opera in cui Franco Ferrarotti racconta che per fraternizzare con Cesare Pavese c’erano molti motivi: lo scrittore era nato nelle Langhe, a Santo Stefano Belbo, Ferrarotti nel Monferrato, a Palazzolo, in provincia di Vercelli, luoghi ad entrambi molto cari e vicini. I due amici furono antifascisti, solidali a respingere «quella cappa di piombo soffocante» che fu la dittatura mussoliniana del tempo, ma che non impedì loro d’essere tormentati nel fisico e nel morale. Pavese però non era un marxista militante e convinto, piuttosto un “comunista eterodosso”.
di GAE SICARI RUFFO – Al Santuario con Pavese. Storia di un’amicizia (Edizioni Dehoniane, pp. 126, € 11,50) è l’intensa opera in cui Franco Ferrarotti racconta che per fraternizzare con Cesare Pavese c’erano molti motivi: lo scrittore era nato nelle Langhe, a Santo Stefano Belbo, Ferrarotti nel Monferrato, a Palazzolo, in provincia di Vercelli, luoghi ad entrambi molto cari e vicini. I due amici furono antifascisti, solidali a respingere «quella cappa di piombo soffocante» che fu la dittatura mussoliniana del tempo, ma che non impedì loro d’essere tormentati nel fisico e nel morale. Pavese però non era un marxista militante e convinto, piuttosto un “comunista eterodosso”.
Si iscrisse al Partito Comunista nel ’46, ma restò critico nei confronti della politica di professione. Non era quella la sua strada, piuttosto quella dell’intellettuale, del traduttore che cercava nuove vie anche americane e quella dello scrittore nello studio di Einaudi dove, subito dopo la guerra, conobbe Ferrarotti, di vent’anni circa più anziano.
Pavese era già in auge ed era entrato insieme a Natalia Ginsburg che aveva per lui molta tenerezza e lo chiamava l’eterno adolescente per via di quella sua aria indecisa.
C’era qualcosa infatti in lui d’indefinito: avresti detto certo la ritrosia, l’attaccamento alla terra e alla casa, ma pure una certa realtà contadina che sembrava portare con sé il profumo del buon tempo antico.
Era stato al confino in Calabria e il suo carattere s’era incupito, anche se non era stato mai espansivo. Al suo ritorno aveva perso la ragazza che gli aveva fatto aveva fatto promessa d’aspettarlo. Incerti del mestiere,ma non sarebbe stata la sola volta! Gli si era creato però il complesso dell’isolamento e non riusciva a confidarsi totalmente per scaricare la coscienza. Gli restava un carattere molto chiuso e riservato, come un grumo con cui doveva fare i conti. Si avvertiva in lui un qualcosa che restava misterioso, ignoto forse pure a se stesso. Ferrarotti stava traducendo il suo primo libro, che sarebbe divenuto poi la sua tesi di laurea in Sociologia (Veblen, The Theory of the Leisure Class), primo traguardo d’una lusinghiera carriera che nel 1951 inizierà con I Quaderni di Sociologia, pubblicati insieme ad Abbagnano. S’intendevano a meraviglia i due amici e riuscivano pure a scherzare. A Pavese piaceva accompagnarsi a lui. Il ricordo più vivo è legato ad una passeggiata verso il Santuario di Crea nel Monferrato. Erano gli anni del Dopoguerra. Non era un periodo sereno. Si respirava ancora l’atmosfera della lotta e degli agguati. I borghi arroccati intorno alle pievi col campanile si alternavano a lunghi e tortuosi sentieri in mezzo a solitarie campagne. I due amici avevano voglia di rilassarsi e di scherzare. Chiamavano i soldati tedeschi in perlustrazione Kartoffeln, per la loro predilezione a mangiare patate per colazione e canticchiavano versi del Faust di Goethe per confondere loro le idee. Si diffondeva nell’aria il suono dolce delle campane che sembra indirizzare il pensiero verso l’alto, verso l’aldilà. Ferrarotti sembra avere accanto il compagno, tanto viva è la sensazione di trovarselo vicino. Pavese, una volta raggiunto il Santuario, fa pure la comunione, tutto compreso in una dimensione che comunque non gli era familiare, ma che lo rimandava indietro nel tempo,all’età della sua infanzia.
L’indifferenza era solo di facciata? Perché allora usava condividere l’agnosticismo critico? D’altra parte ne Il Mestiere di vivere alcune parole in qualche modo possono spiegare il suo stato d’animo:
«Io e credo molti ricerchiamo non ciò che è vero in assoluto,ma ciò che noi siamo. In questi pensieri tu tendi con sorniona noncuranza a lasciar affiorare il tuo essere vero,i tuoi gusti fondamentali,le tua realtà mitiche. Una realtà che non abbia legame radicale nella tua essenza, nel tuo subconscio ecc…, non sai che fartene. In fondo, di Dio ti spiace proprio la sua massima qualità – che è staccato, diviso da te, lo stesso per tutti, eppure una cosa suprema – Ma perché accetti te-quel qualunque che ti succede di essere?».
Non era certo un miscredente. Aveva una sua fede forse senza Dio, che sentiva estraneo. Ma le vibrazioni religiose erano dentro di lui, nella insistente ricerca non dell’effimero, ma dell’eterno. Doveva aver molto pensato all’esistenza e al significato che intendeva attribuirle. Ma spesso rifuggiva dentro di sé da una comoda consolazione che lo avrebbe messo in pace. Era tormentato e insoddisfatto e la sua coscienza ne portava tutto lo strazio. Aveva tentato con l’amore, ma era rimasto fortemente deluso. Cesare Segre intravede ne Il mestiere di vivere una sua misoginia, ma molto probabilmente non era così. La donna era per lui «ispirazione e tormento, premio e dannazione». Fu, la sua, «disperata ricerca della maturità e della pienezza di vita». La depressione gelò sempre i suoi sentimenti, come successe a Kafka. Ci sono uomini che non riescono a vincere il limite dell’immancabile loro infelicità cui si condannano. Il senso di precarietà li accompagna fino a vincerli. Ne La casa in collina c’è un accenno di liberazione e lo smemorarsi potrebbe sembrare l’alternativa alla tristezza e all’inazione, ma Pavese cercava la sua via nei miti. Nei Dialoghi con Leucò, il suo respiro è libero e non si sente defraudato della verità, ma attratto dall’immortalità.
Per la prima edizione, Segre aveva scritto: «Cesare Pavese che molti si ostinano a considerare un testardo narratore realista,specializzato in campagne e periferie americano-piemontesi,ci scopre in questi Dialoghi un nuovo aspetto del suo temperamento».
I suoi miti sono la sua religione: su per i monti, il cielo, la notte ed il giorno prova a narrare quello che gli uomini non sanno più: dov’è la giustizia,a cosa servono le leggi, uomini ospiti o dei ospitati parlano del destino e della morte,ma senza acredine, bensì con incantato stupore.
Avrebbe voluto forse con gli amici condividere la sua decisione di suicidarsi?
Perchélo fece? Praticamente il libro si concentra tutto su queste domande. L’andirivieni degli incontri, il senso dei messaggi, i silenzi protratti accanto alle parole occasionali, gli incoraggiamenti degli amici servono per scandagliare il soggetto, cercano di penetrare nella intimità dello scrittore,ma egli stava in guardia e troncava subito ogni discorso che avrebbe potuto svelare la sua privacy. Non aveva intimità pubblica. Molte cose di lui s’intuivano. Non le raccontava: era molto riservato per sua natura. Non era fatto certo per gli intrighi ed i compromessi. Ne rifuggiva. Era fuori dal suo tempo. Non cercava d’essere al centro della scena,ma si faceva quasi da parte.
Dal biglietto, lasciato accanto al suo cadavere nell’hotel di Torino dove s’era rifugiato il 27 agosto del ’50, sembra lucidissimo: «Perdono tutti e a tutti chiedo perdono. Non fate pettegolezzi». Come se la scena fosse convenzionale e non lo interessasse. Qual è il suo mistero? Era legato alla sua terra, di cui avvertiva gli odori e le forme come una grande risorsa.Ma «guardava dentro l’abisso che vi si era aperto e che l’attirava». Non si uccise per la giovane donna americana che lui aveva amato. Gli amici, anche, tutti fuori. Ferrarotti a Venezia, dopo essersi complimentato con lui per il Premio Strega, al suo rientro da Roma gli aveva promesso di rivederlo presto. Pavese era solo: «Verrà la morte ed[e] avrà i tuoi occhi», aveva scritto. E fu allora che egli vide.
Ha lasciato tanto rimpianto ed un senso di vuoto incolmabile.
Gaetanina Sicari Ruffo
(www.excursus.org, anno VIII, n. 73, giugno 2016)