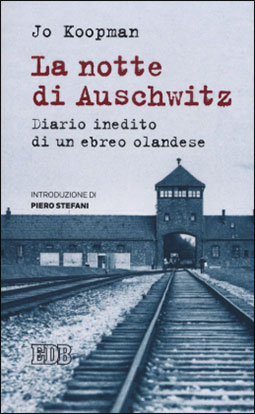 di GAETANINA SICARI RUFFO – Il 27 gennaio di ogni anno è la giornata della memoria, istituita per ricordare il massacro del popolo ebraico compiuto dai tedeschi nella Seconda Guerra Mondiale. Un ricordo che dovrebbe essere perenne se si vuole evitare l’agonizzare della società. Jo Koopman
di GAETANINA SICARI RUFFO – Il 27 gennaio di ogni anno è la giornata della memoria, istituita per ricordare il massacro del popolo ebraico compiuto dai tedeschi nella Seconda Guerra Mondiale. Un ricordo che dovrebbe essere perenne se si vuole evitare l’agonizzare della società. Jo Koopman
“Mai più” è stato detto da più parti, tale è stata l’onda dell’orrore che ha investito il mondo intero nell’apprendere direttamente dai sopravvissuti quanto è successo. E noi, persone umane viventi, ci siamo ripromesse solennemente di perpetuare con tale forte sdegno il ricordo di questa triste storia della disumanizzazione. Questo perché esso non si cancelli facilmente dalle menti dei posteri.
Ora è la volta d’un ebreo olandese a raccontare la sua dolorosa vicenda. Jo Koopman (in La notte di Auschwitz, Edizioni Dehoniane, pp. 144, € 13,00), nato nel 1906 ad Amsterdam è stato catturato, nel ’44, dopo che ha cercato di collaborare con la resistenza. L’Olanda è il paese dell’Europa occidentale in cui s’è registrato il numero più alto di deportati ebrei che non hanno fatto ritorno a casa. Ne sono morti centomila. Il giovane Jo Koopman dalla moglie Alida Breeuver non ebrea ha avuto ben cinque figli tra il 1933 e il 1943. Il padre e la madre, denunciati da un vicino,furono bruciati nelle camere a gas di Auschwitz. Lui mise in salvo la sua famiglia restante, spedendola ad Amersfoort, in provincia di Utrecht, e poi entrò nella resistenza con un falso nome, tra coloro che fabbricavano falsi documenti e reperivano asili per i ricercati. Denunciato a sua volta per ben due volte,venne arrestato il 1 luglio del 1944 e spedito sull’ultimo convoglio per Aschwitz, il 3 settembre.
Ritrovare la vita dopo che ormai pensava lo aspettasse la morte gli sembrò un miracolo. Liberato dai russi e rimpatriato, studiò e si laureò in Economia, entrando poi in politica. Fu deputato nel Parlamento del Partito Socialista del Lavoro ma, non soddisfatto, preferì dedicarsi a consulenze economiche ad alto livello, in paesi come il Kenia, Ghana, Brasile e Bangladesh.
Tra l’agosto del 1945 ed il marzo del 1946, pubblicò a dispense la sua testimonianza quasi in diretta, su un mensile clandestino della Resistenza con il titolo Ebrei Erranti. Successivamente, nel 1975, la sua storia, tradotta in inglese da Curt Wolters, prese il titolo A handful of man.
La narrazione è asciutta e scabra come il suo animo che più che scrivere, fotografa l’orrore di ogni giorno come se fosse presente. «I prigionieri avevano tutti un numero tatuato sul braccio e quello stesso numero sulla giacca e sui calzoni . Con il numero c’era pure un triangolo colorato,rosso per i politici, nero per gli “asociali,verde per i criminali; a seconda che la base fosse rivolta verso l’alto o verso il basso si distingueva se l’esclusione dalla società era temporanea o definitiva». Segue poi tutta una serie di angherie,secondo un ritmo giornaliero di lavoro che non teneva conto né degli orari, né della condizione di salute del deportato. La cosa che tutti temevano era la parola “selezione”, che voleva dire che ogni visita veniva fatta per distinguere i malati dai sani. Venivano in segreto compilate delle liste e poteva succedere, anche il giorno dopo, di essere caricati su di un camion come bestie da macello ed avviati poi alle camere a gas.
Ci si può chiedere come mai centinaia di migliaia di prigionieri (secondo i russi, quattro milioni e mezzo) si siano lasciati condurre alla morte senza reagire, ma una qualsiasi forma di resistenza era impossibile: i prigionieri non avevano armi, né vie di comunicazione con l’esterno. «Un gruppo di prigionieri a Birkenau tentò di ribellarsi, ma cadde sotto i colpi delle mitragliatrici, pur se non finì nelle camere a gas». Nel periodo di Natale il freddo era intenso: meno quindici gradi e talvolta venticinque. Non c’era vestiario sufficiente per coprirsi: una maglia stracciata, qualche paio di brache ed una giacchetta logora. L’avanzare della guerra fu drammatico all’inizio del 1945. Jo Koopman, che si era fatto venire un’infezione alla mano, era ricoverato in ospedale ed i medici avvertirono che il campo sarebbe stato sgomberato. Era cominciata la grande offensiva russa. «Ci aspettava una marcia di duecento chilometri nell’intenzione di raggiungere Breslavia. Quella infezione alla mano mi salvò la vita. Dei diciottomila prigionieri evacuati dal lager,diciassettemila trovarono la morte,decine di migliaia di corpi abbandonati nella neve e poi ritrovati ai bordi delle strade… A quella evacuazione non sopravvisse se non il due per cento dei prigionieri».
Ad una settimana dall’inizio dell’offensiva russa, il lager era stato tutto svuotato e restavano gli ammalati con due medici,ma l’alimentazione idrica e quella elettrica erano state fatte saltare e si pativa la sete. Le notti poi erano agitate, non sapendo cosa sarebbe successo. I russi si facevano aspettare. Poi, dopo che i cannoneggiamenti risuonarono sempre più vicini, due delle truppe d’assalto russe apparvero con tute mimetiche bianche e le armi in pugno, con cautela sul retro del lager.
Era il 27 febbraio del 1945.
Furono accolti con urla di giubilo e abbracci, e allora divenne chiaro a tutti i prigionieri che era stato un vero miracolo se erano rimasti vivi.
Ciò nonostante, furono parecchi a morire anche dopo la liberazione, ridotti a vere larve umane e provati da sì grandi eventi. Si contarono ben cinquecento decessi, dopo l’arrivo dei russi che dimostrarono di essere veramente salvatori. Furono generosi. Alla fine di febbraio, gli ex prigionieri festeggiarono con entusiasmo l’Armata Rossa e addobbarono i locali con disegni e striscioni. Una donna che occupava un alto grado nell’esercito tenne un discorso sul significato della festa e con orgoglio dichiarò che in Unione Sovietica si era giunti alla parità tra uomini e donne. Alle donne del personale militare furono pure affidati compiti di circolazione del traffico nelle città appena occupate dai russi.
Non tutti lasciarono subito il lager per i molti gravemente malati che sentivano il dovere di assistere. I cecoslovacchi si unirono ai russi per prendere parte attiva alla lotta, puntando verso Berlino, altri tentarono d’essere rimpatriati, ma era difficile in quel momento di guerra spostarsi. Comunque, divisi in gruppi, tutti ricevettero dalla Croce Rossa polacca un documento di identità senza limitazioni di circolazione. Auschhwitz era tagliata fuori dal traffico ferroviario per via dei ponti fatti saltare e furono accompagnati con i camion nelle città periferiche. A Katovice, dove giunsero Jo Koopman ed i suoi compagni non senza difficoltà, confezionarono una bandiera che li accompagnò fino ad Odessa in primavera. Qui sfilarono per le vie della città e poi molti s’imbarcarono per Marsiglia.
Il viaggio di ritorno non fu una passeggiata. Dovunque rovine e distruzioni, ma nel cuore di tutti ardeva una nuova speranza che permetteva di sopportare gli ostacoli. Le popolazioni accoglievano gli ex deportati con calore ed entusiasmo. Aprivano le loro case, ansiosi di ospitarli e di parlare con loro. Mille domande ed altrettante adesioni di vicinanza e di affetto. Tutti sembravano ben disposti verso di loro, malgrado tuttavia i dubbi di alcuni compagni che ricordavano il passato della Russia, e che avevano paura che sarebbero stati trattenuti. Il 1° maggio a Odessa ci fu una grande festa: sfilate, fiori, bandiere e vodka, all’annuncio dato da Stalin della resa della Germania.
E fu a questo punto che le autorità russe scovarono in mezzo agli aspiranti del rimpatrio alcune Ss che si erano mimetizzate per salvarsi senza processo. Giunse finalmente dopo lungo tempo l’imbarco tanto sospirato per il porto di Marsiglia e poi l’Olanda, la meta tanto attesa. Il diario resta una testimonianza toccante del recupero della vita e la memoria straziante delle vittime innocenti, di sperimentazioni terribili, di crimini inenarrabili e di odio razziale.
Gaetanina Sicari Ruffo Jo Koopman
(www.excursus.org, anno X, n. 89, agosto-settembre 2018) Jo Koopman








