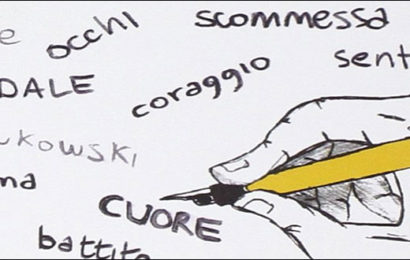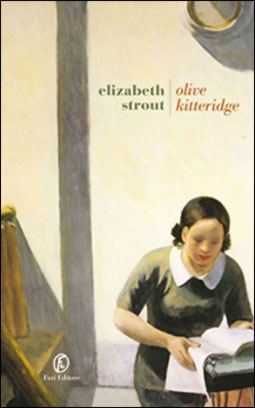 di ALICE TORREGGIANI – «Avvertì la massiccia presenza di lei e immaginò fugacemente un elefante seduto lì accanto, desideroso di entrare a far parte del regno umano; dolce e innocente, con i tronconi delle zampe anteriori ripiegati in grembo e il torso che si agitava appena mentre finiva di parlare». Un elefante impacciato, una donna in cerca di affetto, questa è Olive Kitteridge (traduzione di Silvia Castoldi, Fazi Editore, pp. 383, € 18,50), titolo e personaggio trainante del romanzo di Elizabeth Strout, Premio Pulitzer nel 2009.
di ALICE TORREGGIANI – «Avvertì la massiccia presenza di lei e immaginò fugacemente un elefante seduto lì accanto, desideroso di entrare a far parte del regno umano; dolce e innocente, con i tronconi delle zampe anteriori ripiegati in grembo e il torso che si agitava appena mentre finiva di parlare». Un elefante impacciato, una donna in cerca di affetto, questa è Olive Kitteridge (traduzione di Silvia Castoldi, Fazi Editore, pp. 383, € 18,50), titolo e personaggio trainante del romanzo di Elizabeth Strout, Premio Pulitzer nel 2009.
Personaggio carismatico e complesso, Olive è un’insegnante di matematica in pensione in un tipico paesino della provincia americana. È una donna ingombrante in tutti i sensi: il suo fisico imponente e la sua personalità forte, a tratti prepotente e rude, la rendono una persona con cui è difficile convivere o semplicemente dialogare. Fin dalle prime pagine si dimostra una donna dura e di un cinismo quasi comico, che si abbatte sull’ingenuità e il candore delle persone che la circondano, che ne rimangono profondamente colpite, a volta addirittura ferite.
Ma, tra una critica e un arricciamento di naso, Olive rivela anche grande empatia, soprattutto per coloro che si trovano in difficoltà e che chiedono, anche se non esplicitamente, aiuto. Un ex studente che medita il suicidio, una ragazza afflitta dall’anoressia, il suo stesso figlio vittima della propria estrema sensibilità. Persone che il resto della comunità ignora per indifferenza o superficialità, ma in cui lei è in grado di intravedere la sofferenza. Una sofferenza che la lascia sconvolta e che la porta a formulare pessimistici pensieri sull’esistenza e sull’uomo, ogni tanto interrotti da rari sprazzi di gioia di vivere e di felicità, quando Olive rimane sorpresa di constatare quanto, nonostante tutto, le persone siano testardamente attaccate alla vita, desiderose di continuare ad esistere e di ottenere ciò di cui hanno bisogno.
«[…] in quel momento Olive aveva avvertito un sentimento che non si aspettava più di provare: un improvviso impeto di avidità per la vita. Si era sporta in avanti, sbirciando fuori dal finestrino: dolci nuvolette bianche, il cielo azzurro come il suo cappello, il verde novello dei campi, la grande distesa d’acqua: visto da lassù tutto appariva meraviglioso, sorprendente. Ricordò che cosa fosse la speranza: era ciò che provava in quel momento».
La vita appare come un mare di terrore in cui gli uomini annaspano per sopravvivere e per raggiungere un’illusione di felicità, magari attraverso l’amore. Ma neanche questo, in fin dei conti, sembra riuscire a salvarli davvero, poiché essi rimangono condannati ad un’eterna e irrimediabile solitudine, da cui non possono in alcun modo fuggire: si nasce soli e si muore soli. La solitudine è forse il tema attorno a cui ruota l’intero romanzo e su cui la protagonista si interroga senza trovare una risposta definitiva. Formula però un’interessante teoria, ovvero che nella vita esistono “grosse esplosioni”‒ gli eventi che ti cambiano la vita, i pilastri dell’esistenza di una persona ‒ e “piccole esplosioni”. Queste sono le più importanti, quelle di cui si sente un bisogno impellente e primitivo: sono i piccoli gesti della quotidianità che trasmettono solidarietà, amicizia, vicinanza e che rendono la condizione umana più sopportabile, addirittura felice.
Tutti i personaggi sono accomunati da un dolore sordo che li accompagna per tutta la vita; sono persone normali con angosce e sofferenze private e intime, nascoste agli occhi della comunità. Ciò che Elizabeth Strout riesce a fare con grande maestria è mostrare come ogni famiglia, anche quella all’apparenza più felice e perfetta, nasconda una più o meno grande tragedia. E lo fa senza scadere nel patetismo o nel dramma, ma con una leggerezza sorprendente, spesso persino con ironia, ma senza mai perdere profondità e, soprattutto, senza mai fornire un giudizio morale sull’operato dei suoi personaggi. Elizabeth Strout si limita a riportare le loro storie, come un osservatore invisibile e imparziale.
Molto interessante è anche a struttura del romanzo, che si compone di tredici racconti, in cui protagonisti sono di volta in volta diversi abitanti del paese, che mettono in scena la propria personale tragedia e riappaiono come comparse in quelle degli altri. È un paese uguale a tanti altri e che, proprio per questo, diventa paradigma e specchio di una realtà molto più ampia, universalmente condivisibile. Olive è il filo che lega tutti i racconti e, in qualche modo, sembra legare anche l’intera comunità, in quanto insegnante e in quanto donna e madre di famiglia.
Nel leggere sembra quasi di sfogliare un album di fotografie o di osservare una serie di quadri, ognuno dei quali immortala un momento di una vita, di un’esistenza, e ne racconta la storia. O anche pezzi di un puzzle che pian piano si incastrano dando al lettore un’immagine completa della cittadina. Questa forma di narrazione, questo romanzo in racconti, ha il grande pregio di catturare il bello di entrambe le tipologie: la densità e la forza espressiva del racconto, e la capacità di coinvolgere e far immergere del romanzo, la capacità di esplorare, pagina dopo pagina, una moltitudine di figure e di storie.
Olive Kitteridge è un personaggio scomodo, che all’inizio si odia o si compatisce, ma che poi si finisce inevitabilmente per comprendere e amare, perché è un tuttotondo perfetto, un concentrato di emozioni talmente umane e universali che è impossibile non condividere, non conoscere. Dà voce ai pensieri più profondi che ognuno di noi nasconde, anche quelli più intimi, anche quelli per cui proviamo vergogna.
Alice Torreggiani Elizabeth Strout
(www.excursus.org, anno X, n. 88, marzo-aprile 2018) Elizabeth Strout