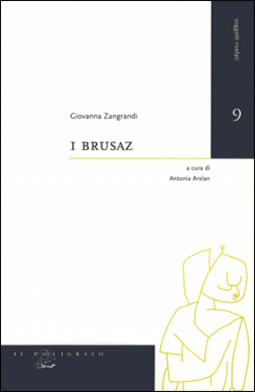 di FEDERICA CHIMENTON – Le scrittrici conosciute ai più che nel corso del Novecento hanno parlato della Resistenza si possono purtroppo contare sulle dita di una mano. Esiste infatti un’intera dimensione semisconosciuta di donne che hanno combattuto affianco agli uomini per sconfiggere il fascismo e nel Dopoguerra hanno sentito il bisogno di raccontare e far conoscere quella parte di Storia nascosta e poco narrata. Una di queste scrittrici è Giovanna Zangrandi: una donna forte, contraddittoria e sola, la cui personalità emerge nel romanzo I Brusaz (a cura di Antonia Arslan, Il Poligrafo, pp. 220, € 20,00).
di FEDERICA CHIMENTON – Le scrittrici conosciute ai più che nel corso del Novecento hanno parlato della Resistenza si possono purtroppo contare sulle dita di una mano. Esiste infatti un’intera dimensione semisconosciuta di donne che hanno combattuto affianco agli uomini per sconfiggere il fascismo e nel Dopoguerra hanno sentito il bisogno di raccontare e far conoscere quella parte di Storia nascosta e poco narrata. Una di queste scrittrici è Giovanna Zangrandi: una donna forte, contraddittoria e sola, la cui personalità emerge nel romanzo I Brusaz (a cura di Antonia Arslan, Il Poligrafo, pp. 220, € 20,00).
L’autrice
Giovanna Zangrandi nasce a Galliera, nel bolognese, nel 1910, con il nome di Alma Bevilacqua, figlia unica di Maria Tardini e Gaetano Bevilacqua, entrambi socialisti e spesso descritti dall’autrice come stoici, anche se infelici. Dopo un po’ di tempo, la famiglia lascia il paese natio, con il vano intento di migliorare la salute del padre che aveva iniziato a manifestare i primi segni di una grave schizofrenia congenita. Gaetano si suicida nel 1912, un gesto estremo che Giovanna nei suoi diari personali considera «più come eutanasia, che come suicidio».
L’infanzia serena, immersa in una dimensione naturale, quasi panica, si converte in una crescita dolorosa, segnata dalla sofferenza e dalla solitudine.
Nel 1923 Giovanna e la madre si trasferiscono a Bologna dove sono aiutate economicamente da uno zio paterno che costringe la ragazza a frequentare studi classici, ritenendo egli il liceo scientifico inutile. Da questo momento Zangrandi inizia a sviluppare un odio nei confronti di Bologna, città estranea e ostile, confortata solo dagli unici momenti sereni quali le vacanze estive trascorse nelle montagne cadorine.
Alla morte della madre nel 1937 Giovanna decide di tagliare i ponti con la famiglia per iniziare una nuova vita in mezzo alla natura trasferendosi a Cortina, dove svolge la professione di insegnante. Lo spostamento segna simbolicamente l’inizio di una nuova vita; cancella le sue origini per diventare “cadorina d’adozione” e comincia a collaborare con diverse riviste e a cimentarsi con la scrittura, che sente essere la vera vocazione della vita.
L’ombra della guerra si abbatte negli anni seguenti nelle pacifiche montagne cadorine e a un’iniziale e controversa adesione al fascismo segue una militanza attiva nelle file della Resistenza a partire dal 1943. Durante i primi tempi nasconde i disertori aiutandoli a fuggire; successivamente Giovanna Zangrandi diventa staffetta con il nome di battaglia “Anna”. Il suo compito è trasportare messaggi, vettovaglie, cibo e armi da un confine all’altro, dal momento che la sua professione le concede di recarsi a Pieve, al confine con il Terzo Reich. Nel 1945 fonda la rivista partigiana Val Boite e, nello stesso anno, è costretta a vivere in clandestinità tra le montagne per scampare alla cattura da parte dei tedeschi. Da queste esperienze trarrà spunto per scrivere I giorni veri, edito nel 1963, costruito come un diario ma intrecciando la documentazione storica della Resistenza ad un’analisi intima, tanto da creare così una scrittura auto-narrativa.
I Brusaz
Il Dopoguerra è segnato dalla nascita di un sentimento ostile nei confronti di Cortina e della mentalità provinciale che la contraddistingue, ma allo stesso tempo corrisponde al periodo di maggiore operosità artistica della scrittrice. Tra le opere spicca il romanzo I Brusaz – romanzo pubblicato nel 1954 e vincitore del Premio “Grazia Deledda” – e Il campo rosso: cronaca di un’estate, 1946 (1959), in cui elementi autobiografici si intrecciano alla sperimentazione, peculiarità dell’autrice.
La scrittura per Giovanna Zangrandi è perfettamente complementare alla sua capacità di scavare nell’animo umano e di guardare dentro le misere vite della gente, che trasfigura poi nei suoi scritti. Non a caso nei suoi diari ammetterà: «Io penso di arrivare a fare cose più grandi delle mie forze, di dovere scrivere le storie di queste vite rubate come per dovere di rendere quello che si rubò, di arrivare non si sa dove, infinitamente lontano e su limpidi valichi come quando la bava mi cola sui ghiaioni». Allo stesso tempo però sente la necessità di scrivere per se stessa. La scrittura non è altro che un mezzo di introspezione quotidiana. Ed è esattamente ciò che incontriamo ne I Brusaz, romanzo che parla delle donne e della maternità, della montagna e della natura, della povertà e della dignità. Il romanzo segue la storia e gli amori di Sabina Brusaz, delle sue fasi di maturazione come donna, ciascuna identificata con le tre sezioni in cui è diviso il libro.
Nella prima parte la giovane donna risiede con la famiglia a Hoden, piccolo villaggio delle Dolomiti vicino al confine con l’Austria. Qui Sabina si innamora di Donato Brusaz, un giovane lavoratore che viene dal povero villaggio di Iugol, ingaggiato dalla famiglia di Sabina per tagliare il fieno durante l’estate. Donato la sposa dopo averla sedotta e messa incinta ma Sabina viene ripudiata dalla sua famiglia e dal suo villaggio. Si trasferisce pertanto nel paese natio di Donato dove, dopo la partenza del marito per l’America, vive sola con la suocera Tesa, personaggio controverso ed emblematico della condizione femminile di Iugol. Al termine della prima parte, Sabina completa il suo processo di maturazione con la nascita del figlio Pino.
Nella seconda sezione, ambientata durante gli anni della Grande Guerra, Sabina incontra il tenente Oreste Muzziero, il quale nutre per lei un sentimento di un amore quasi mitico. Egli infatti considera Sabina una divinità, chiamandola Gea. Tuttavia, così come Donato ha cercato fortuna in America, Muzziero la cerca in Australia, non tornando più e lasciandola sola ad allevare il figlio Guido avuto da lui.
L’ultima parte invece vede al centro della narrazione il profondo sentimento tra Sabina e Tommaso Da Port, dal cui amore nasceranno due figli. Ne emerge una famiglia serena che vive tra la bellezza del paesaggio delle montagne e cerca di realizzare i proprio sogni, che purtroppo non potranno essere realizzati a fronte di una disgrazia incombente.
Il romanzo presenta due schieramenti contrapposti di personaggi: da una parte gli uomini, fantocci assenti, dall’altra le donne, vere protagoniste della storia. Sabina è il fulcro di una compagine narrativa di donne accomunate da un destino di morte da cui lei emerge però come una vera e propria Madre Natura che non appartiene a nessuno, se non a se stessa. «Una volta vi era un uomo nel suo lettuccio. Quando? Vi era, vi fu […] Ed il viso dell’uomo non si vede più, è come il viso di un morto […]» (pp. 125-126).
Lo stile di Giovanna Zangrandi si caratterizza per la costante sperimentazione letteraria autonarrativa, con la quale compensa le gravi mancanze di affetti, amore e soprattutto maternità attestati nel corso della sua vita, e per la puntualità rigorosa che è eco dei suoi studi scientifici universitari.
Dai suoi diari infatti emerge da un lato la rabbia contro un Dio-padrone per aver intaccato i discendenti della tara e per averle dato questo peso da sopportare; dall’altro la convinzione che legarsi a un uomo non fosse suo destino. Ciò nonostante, i figli restano l’elemento vitale della donna, motivo per cui la scrittura assume il ruolo di risarcimento e compensazione: questa infatti sostituisce la prole reale, che la solitudine autoinflitta non le può concedere, con creazioni letterarie che le somigliano. Così facendo Giovanna Zangrandi si riappropria della sua funzione primaria, ovvero essere madre, attraverso la scrittura, riuscendo così a esorcizzare la tara. Il suo intento ultimo altro non è che trasferire frammenti della propria esistenza e del proprio passato per raggiungere una ricomposizione di sé necessaria ed esorcizzante.
Giovanna Zangrandi è un’autrice da riscoprire perché riesce a costruire personaggi tanto innovativi quanto tradizionali sebbene le ambientazioni siano estremamente delimitate, le vicende, le sensazioni e soprattutto le reazioni e i giudizi della comunità sono valide dall’estremo Nord all’estremo Sud.
Federica Chimenton
(www.excursus.org, anno X, marzo-aprile 2018)








