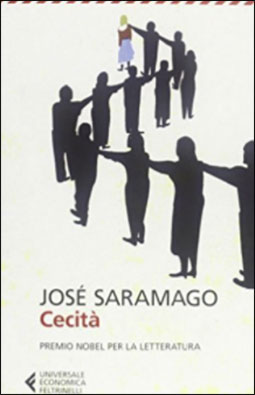 di ALESSANDRA QUAGGIA – Il libro Cecità (traduzione di Rita Desti, Feltrinelli, pp. 276, € 9,50) di José Saramago, come molte sue opere, non ha una collocazione storica precisa, né dei personaggi aventi un nome. I protagonisti sono definiti per alcune loro caratteristiche fisiche o professionali: il medico e la moglie del medico, il vecchio con la benda nera, il ragazzino strabico, la donna dagli occhiali scuri, il primo cieco e la moglie del primo cieco.
di ALESSANDRA QUAGGIA – Il libro Cecità (traduzione di Rita Desti, Feltrinelli, pp. 276, € 9,50) di José Saramago, come molte sue opere, non ha una collocazione storica precisa, né dei personaggi aventi un nome. I protagonisti sono definiti per alcune loro caratteristiche fisiche o professionali: il medico e la moglie del medico, il vecchio con la benda nera, il ragazzino strabico, la donna dagli occhiali scuri, il primo cieco e la moglie del primo cieco.
Il motivo sembra semplice: in una condizione di cecità collettiva, che importanza potrebbe avere come si chiamano? Eppure è attraverso i nomi che oggi noi ci orientiamo nel mondo. Diamo definizioni a qualsiasi cosa, sia essa vivente o meno. Siamo convinti che definire le cose sia l’azione più importante da fare per poter comprendere il mondo che ci circonda, e forse dimentichiamo che, oltre alle definizioni e ai nomi, ci sono gli esseri viventi stessi. Ma che fare se una mattina, all’improvviso, non riuscissimo più a definire i contorni del viso di chi ci parla, il perimetro della stanza in cui ci troviamo e, addirittura, i confini della città in cui viviamo, in quanto completamente immersi in «un mare di latte»?
Saramago ci catapulta in un incubo dal quale non possiamo scappare perché sembra doverci insegnare qualcosa. Intreccia la nostra paura con quella dei protagonisti e di tutti gli altri abitanti, costretti a sopravvivere come meglio possono, spesso arrivando ad oltrepassare il confine dell’umano. Ma non è questo un “oltre-passamento” verso qualcosa di migliore. È un ritorno alle origini. Origini per l’uomo e non per l’ambiente. Non è il rimando ad uno “stato di natura” perché, se lo fosse, l’uomo potrebbe ricominciare ad «organizzarsi».
La società che invece l’uomo ha costruito per avere tutto più a portata di mano ora gli si ritorce contro. E non solo la città diventa invivibile fisicamente, perché nessuno può indicare ad un altro la strada da percorrere, ma anche le leggi, che con tanta tenacia e passione l’uomo ha sempre difeso, diventano inosservabili o persino assurde.
Scorrendo le pagine sorge spontanea chiedersi se il modo con cui abbiamo cercato da sempre di comprendere il mondo sia giusto o se, in realtà, «non abbiamo fatto degli occhi una sorta di specchi rivolti all’interno». La risposta ci viene fornita mediante una sola persona: la moglie del medico. Essa è l’unica in grado di vedere tutto. Per quale motivo proprio lei? Perché non il marito medico che ricopre un ruolo molto importante all’interno della società? Saramago non lo rivela. Ma è attraverso lei che noi, allo stesso modo dei protagonisti, riusciremo ad affidarci alle avventure del libro. I suoi occhi continuano a vedere ed osservano tutto, a volte anche ciò che una persona qualunque non riuscirebbe a guardare. Ed è forse qui che sta la differenza fra lei e le altre figure della storia. Lei non sembra vedere distrattamente, ma guarda. I suoi occhi non sembrano rivolti a se stessa ma rivolti al mondo circostante. Fin da subito. Fin dall’inizio del racconto.
Questa figura “salvifica” è un tema ricorrente anche in altre opere (come Caino o Il Vangelo secondo Gesù Cristo), ed è per questo motivo che l’autore spesso ha dovuto affrontare diverse controversie con il mondo della Chiesa Cattolica in quanto avente idee troppo “rivoluzionarie”per il mondo religioso.
Ma Saramago non lo si può definire un rivoluzionario solo per i temi che tratta, ma anche per il modo in cui li tratta. Il suo stile, infatti, è assai caratteristico. È composto da periodi molto lunghi e da un utilizzo insolito della punteggiatura. I dialoghi, ad esempio, vengono introdotti da una virgola e dalla lettera maiuscola, non da virgolette. Questo suo distinguersi dalle norme classiche della scrittura è forse anch’esso un modo per ricordarci di non abbassare mai lo sguardo, di non affidarci alle norme convenzionali, ma di metterle in dubbio. Forse perché se le norme di scrittura possono, se usate senza ragione, solo creare un brutto racconto, le norme che regolano la nostra vita potrebbero risultare invece devastanti, se osservate ed applicate senza contestualizzarle.
Ed è quello che accade proprio all’interno del racconto. Il primo modo per difendersi dall’epidemia – così verrà chiamata – sarà quello di affidarsi alle forze armate perché loro, esperienza vuole, sanno cosa fare in questi casi. E così i ciechi verranno deportati in un plesso e allontanati dalla comunità. E sarà proprio da quest’istante che diverrà sempre più visibile la paura. Paura che ogni personaggio prova, il medico di fronte all’impotenza del suo ruolo, il primo cieco di fronte all’incapacità di guidare e così via. Anche la moglie del medico ha paura e spesso si trova a tremare; ma ha un qualcosa in più ed è per questo che sarà proprio lei a dire che «la paura non sempre è buona consigliera». È come se lei avesse un rapporto più stretto con l’esterno rispetto agli altri e proprio perché avente questo rapporto più stretto con l’altro, con il diverso da sé, avesse un rapporto diretto anche con se stessa e con i sentimenti.
Lasciamo al lettore la voglia di scoprire quale rapporto si stia cercando di trattare all’interno di questo volume perché solo attraverso l’esperienza della lettura si può intuire ciò che l’autore vuole comunicarci.
Quest’opera non sembra essere solo un romanzo fantastico ed immaginario, una storia troppo violenta per essere vera, e dunque un racconto che voglia portare solo terrore e ribrezzo nel mondo del lettore. Esso è un qualcosa che se osservato e guardato attentamente può aiutarci a non vivere «come montoni al macello, belando come al solito […] pelo contro pelo, fiato contro fiato, odore contro odore».
Alessandra Quaggia Saramago
(www.excursus.org, anno IX, n. 86, settembre-ottobre 2017) Saramago








